Il datore di lavoro e i limiti nella richiesta di restituzione al lavoratore
di Stefano Ferri *
Uno dei temi che periodicamente si ripropongono è quello della restituzione di somme da parte del lavoratore, ad esempio perché parte datoriale ha corrisposto indebitamente importi non dovuti. Questa tematica è stata affrontata, analizzata e risolta più volte dalla Corte di Cassazione, recentemente con la sentenza n. 517 pubblicata l’11 gennaio 2019 che ritengo opportuno esaminare in questo articolo sia per la sua chiarezza e sia perché consolida un principio già affermato.
La vicenda processuale era pervenuta alla Suprema Corte a seguito di pronuncia della Corte di Appello di Firenze che, con sentenza n. 1428/2013, tra l’altro respingeva le richieste della società, affermando che, versando le ritenute fiscali e contributive nella veste di sostituto di imposta, il datore di lavoro aveva adempiuto un’obbligazione propria e non un’obbligazione del dipendente in veste di suo rappresentante.
Per correttamente approcciare la fattispecie è bene prendere le mosse dal dettato testuale dell’odierno articolo 38 del d.p.r. 602/73, che testualmente prevede che: “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento. L’istanza, di cui al primo comma, può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”. Dall’analisi testuale della norma risulta evidente che è il soggetto che ha effettuato il versamento che può, in via principale, presentare istanza di rimborso delle imposte, sia in caso di errore materiale che di duplicazione od inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento; viene comunque consentito anche al percipiente/ sostituito di presentare tale istanza. E in tale direzione si rammentano numerose sentenze della Corte di Cassazione: tra le ultime in tal senso si segnala la n. 19735 del 25 luglio 2018.
Ritornando alla sentenza 517/2019, la Suprema Corte ha correttamente ritenuto che la pronuncia impugnata abbia inquadrato il caso in esame nelle ipotesi di inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento (che rientra in una ipotesi di errore), dato che l’obbligo fiscale sorto da sentenza poi riformata è venuto meno con effetto ex tunc per effetto della parziale riforma in appello (vedasi in tal senso sentenza di Cassazione n. 6072 del 2012). Pertanto, ci troviamo nell’ipotesi di inesistenza dell’obbligo di versamento o di errore e la conseguente azione di restituzione e riduzione in pristino (tra le altre, in questa direzione, sentenza n. 21699 del 2011) si collega ad un’esigenza di restaurare la situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza con riferimento a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, e quindi giuridicamente si tratta di un pagamento non dovuto.
Aggiungasi, inoltre, che sempre la Suprema Corte, con sentenza n. 239 del 11 gennaio 2006, ha stabilito un principio di diritto in base al quale il datore di lavoro, con riferimento ai versamenti contributivi nelle assicurazioni obbligatorie, come previsto dall’art. 19 della legge n. 218 / 1952, è responsabile del pagamento dei contributi anche per la quota a carico dei lavoratori da lui trattenuta in busta-paga; è pertanto direttamente obbligato verso l’ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori che egli trattiene sulla retribuzione, e di conseguenza, in caso di indebito contributivo, parte datoriale è la sola legittimata all’azione di ripetizione dei confronti dell’ente anche con riguardo alle quote trattenute e versate.
Nella sentenza in esame, quindi, dato che è pacifico che siano state operate le ritenute fiscali sulle retribuzioni spettanti, la società, a prescindere da ogni altra considerazione, non avrebbe potuto ripetere le somme a tale titolo pretese nei confronti del lavoratore perché appunto da questi non percepite. Viene, pertanto, confermato il principio, già sancito in precedenza da copiosa giurisprudenza anche di Cassazione (tra le varie si rammenta la n. 1464 del 2 febbraio 2012), in base al quale il datore di lavoro non può pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali, qualora le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente; tale principio vale anche nel rapporto di pubblico impiego, come sancito dal Consiglio di Stato (sezione 6 – 1164 del 2/3/2009).
Il tutto conferma la ormai risalente, ma sempre attuale, tesi ben esposta nella sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torino del 6/4/2004 che stabiliva che qualora il datore di lavoro, dopo aver indebitamente corrisposto delle somme al proprio dipendente, gliene richieda la ripetizione, il lavoratore è tenuto alla restituzione delle sole somme ricevute al netto delle trattenute fiscali, non potendo essere condannato a restituire somme che non ha concretamente percepito, ma che sono state versate al fisco dal datore di lavoro quale sostituto di imposta.
Tale impostazione, allo stato, deve intendersi consolidata.
* Odcec Reggio Emilia

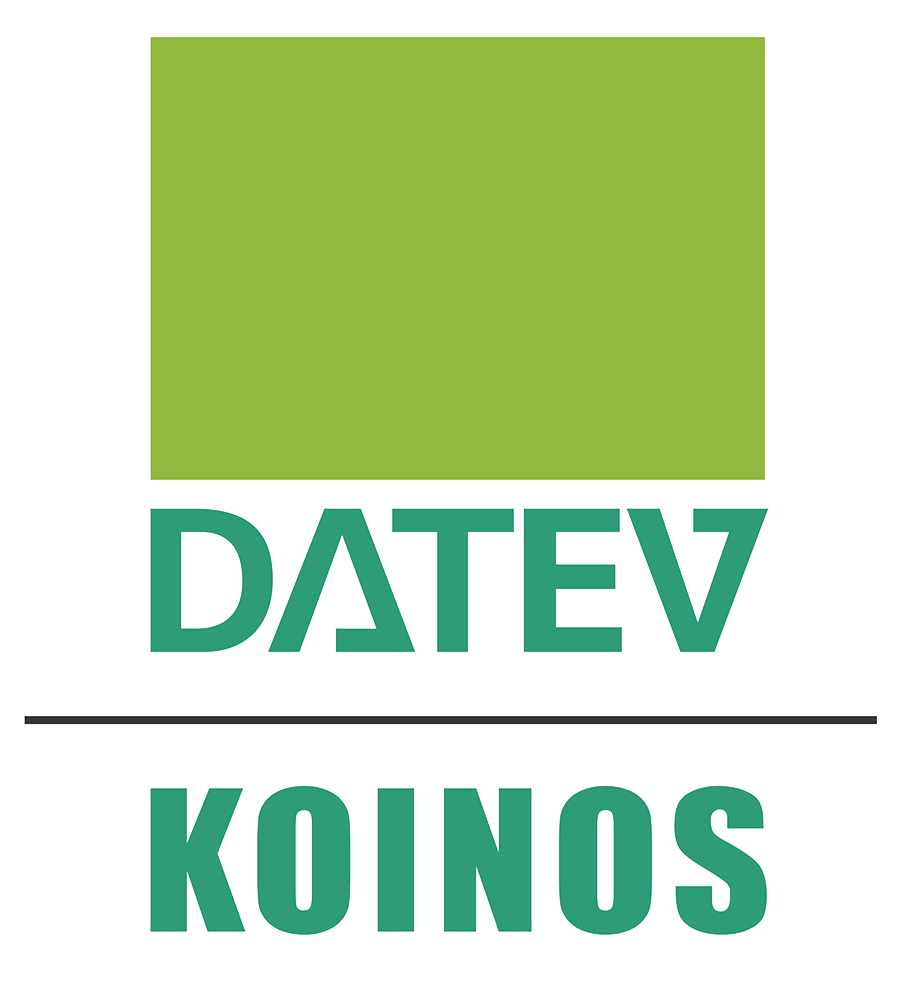






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!