Tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero
di Paolo Soro*
Accade sempre più di frequente che un cittadino italiano si rechi a lavorare all’estero, alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o straniero, ed il presente elaborato intende illustrare brevemente l’argomento della tassazione dei redditi conseguenti.
In base ai principi generali di gran parte degli ordinamenti tributari, tutti i redditi dovrebbero essere tassati nel paese in cui sono concretamente prodotti. Peraltro, da un lato, non tutti gli stati adottano gli stessi principi impositivi, e, dall’altro, giocano un ruolo preponderante (specialmente in assenza di uno specifico trattato convenzionale contro le doppie imposizioni) i fattori che consentono di definire il luogo di effettiva residenza del soggetto. Prima di tutto, dunque, occorre stabilire quali sono i presupposti in funzione dei quali la residenza fiscale permane Italia, anche nel caso in cui ci si rechi a lavorare all’estero. L’art. 2, comma 2, del DP.R. 22 dicembre 1986, n. 917 “Testo unico delle imposte sui redditi” (TUIR) elenca tre condizioni fra loro alternative; ovverossia, è sufficiente il verificarsi anche di una sola di esse, perché il soggetto sia qualificato come residente del territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta:
- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del Codice Civile;
- hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del Codice Civile.
[Per semplicità di trattazione, daremo uno sguardo in appendice al comma 2-bis che concerne le ipotesi relative al lavoro presta- to in Stati o territori considerati “paradisi fiscali”.]
Occorre fare subito un’importante precisazione: con la locuzione “maggior parte del periodo d’imposta”, si intende un intervallo di tempo superiore a 183 giorni, da computarsi all’interno del medesimo anno solare. Dopo di che, per determinare la base imponibile, viene in aiuto il successivo art. 3, al comma 1, il quale stabilisce che l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto; vale a dire:
- per le persone fisiche qualificate come fiscalmente residenti in Italia, tutti i redditi posseduti ovunque prodotti (c.d. worldwide principle taxation);
- per i non-residenti, soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato (principio di territorialità del reddito).
Da quanto sopra esposto, il dipendente che si trasferisce all’estero per prestare la propria attività lavorativa, restando peraltro fiscalmente residente in Italia (perché continua ad avervi un domicilio o una residenza, ovvero semplicemente perché non ha provveduto a cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente, per iscriversi all’AIRE – Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), resterà obbligato a versare le imposte su tutti i redditi nel nostro Paese, anche quelli effettivamente prodotti all’estero, con conseguente possibile doppia imposizione temporanea, ferma restando la concessione di un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, in funzione a quanto determinato dall’art. 165 del TUIR.
Con riferimento a coloro che risultano residenti in Italia ai sensi del citato art. 2, l’art. 51, comma 8-bis, del TUIR, in de- roga alle regole di determinazione analitica della base imponibile, dispone che il reddito di lavoro dipendente prestato fuori dall’Italia, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da coloro che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto ministeriale. Tali retribuzioni sono state introdotte in ambito previdenziale, in quanto rilevano per il calcolo dei contributi relativi alle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, o comunque per le assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti. Per quantificare il reddito imponibile di questi lavoratori, pertanto, non si tiene conto delle retribuzioni effettivamente corrisposte. In più, se il datore di lavoro riconosce al dipendente dei fringe benefit, questi non dovrebbero venire tassati autonomamente, in quanto ricompresi forfetariamente nella retribuzione convenzionale.
Il requisito dell’esclusività è soddisfatto quando la prestazione di lavoro all’estero costituisce l’unica attività affidata al dipendente e non è quindi accessoria o strumentale rispetto allo svolgimento di mansioni in Italia (a esempio, per compiere trasferte o missioni presso clienti stranieri, fiere o società collegate all’estero). In pratica, l’unico oggetto del rapporto di la- voro tra azienda e dipendente deve essere lo svolgimento di attività lavorativa all’estero. E’ necessario (circolare ministeriale 207/2000) stipulare uno specifico contratto che prevede l’esecuzione della presta- zione in via esclusiva all’estero e collocare il dipendente in uno speciale ruolo estero.
Il concetto di continuità va, viceversa, riferito al fatto che l’incarico deve esse- re stabile, ossia non di tipo occasionale. Attenzione che (sempre secondo la citata circolare), la continuità non riguarda il periodo di permanenza all’estero: è sufficiente, infatti, che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni “nell’arco di dodici mesi”, da intendere non come periodo d’imposta, ma facendo riferimento alla permanenza all’estero stabilita nel contratto, possibile anche per un periodo a cavallo di due anni solari. Nel conteggio dei 183 giorni rientrano anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi. Relativamente a detto periodo, da notare che, mentre appare condivisibile l’interpretazione data dal Ministero con riferimento al periodo da considerarsi an- che a cavallo di due differenti anni solari, posto che la norma dice semplicemente “nell’arco di dodici mesi”, appare viceversa non corretto parlare di un minimo di 183 giorni, avuto riguardo al preciso tenore letterario della disposizione che afferma chiaramente: “soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni”.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Decreto 25 gennaio 2016, ha fornito le indicazioni concernenti il corrente anno 2016, in merito alle retribuzioni convenzionali. Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. Sulle retribuzioni convenzionali andrà liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, i valori convenzionali dovranno essere divisi in ragione di ventisei giornate. Ricordiamo, infine, che la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, non viene applicata se il lavoratore presta la propria attività in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni, e tale trattato prevede, per il reddito di lavoro dipendente, la tassa- zione esclusivamente nel Paese estero. In questo caso, infatti, la normativa convenzionale prevale sulle disposizioni fiscali nazionali.
Riepilogando, dunque, i redditi derivanti da un’attività prestata all’estero saranno assoggettati a:
- tassazione su base convenzionale, se derivano da un’attività prestata all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni e rimangono fiscalmente residenti in Italia;
- tassazione con le ordinarie regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, se i redditi derivano da un’attività prestata all’estero, ma non sussistono i predetti requisiti.
Sulla base di quanto precede, il dipendente all’estero che abbia mantenuto la residenza fiscale in Italia potrebbe trovarsi nella situazione di dover versare le imposte in Italia sul reddito di lavoro di- pendente e, allo stesso tempo, dover pagare pure nello Stato estero in cui svolge la propria attività lavorativa. Non sempre, infatti, arrivano in soccorso le convenzioni contro le doppie imposizioni.
Dando uno sguardo all’applicazione pratica della norma, la circolare INPS 72/1990 aveva affermato che: “La fascia di retribuzione imponibile è determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente.” In proposito, si rende noto che il Ministero del lavoro – Direzione generale e della previdenza e assistenza sociale – ha avuto modo di precisare che: “Ai fini dell’attuazione del predetto articolo, per ‘retribuzione nazionale’ deve intendersi l’importo mensile determinato dividendo per 12 il trattamento da contratto collettivo previsto per il lavoratore, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero”. Medesimo principio, peraltro, era già stato espresso anche nella Circolare INPS 141/1989, la quale prevedeva che: “In merito alla determinazione della retribuzione imponibile per i lavoratori assicurati in regime di legge n. 398/1987:
- la contribuzione deve essere riferita per la generalità dei lavoratori alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità all’anno;
- il passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese comporta, con la stessa decorrenza, l’attribuzione ai fini di cui trattasi della retribuzione convenzionale corrispondente alla nuova qualifica;
- il trattamento mensile per le qualifiche di quadro, dirigente e giornalista, evidenziato nel M. 14 febbraio 1989 ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere determinato dividendo per dodici il trattamento da contratto collettivo previsto per il lavoratore a seconda della qualifica rivestita e della sua collocazione nell’ambito della qualifica stessa;
- il mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di quadro, dirigente e giornalista, o per passaggio di qualifica, comporta l’attribuzione, ai fini in discorso, con la stessa decorrenza, della retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.”
Possiamo, di conseguenza affermare che, sia a livello ministeriale che in dottrina, si concordava sul fatto che la retribuzione di riferimento da contratto collettivo fosse da identificarsi con la retribuzione contrattualmente garantita individualmente al dipendente (minimo, superminimo etc.), con esclusione degli elementi varia- bili (bonus discrezionali), nonché degli eventuali benefit e indennità legate all’attività prestata all’estero. Senonché, l’INPS, dopo aver implicitamente avvallato tale modus operandi ogni anno (nelle circolari di accompagnamento alle retribuzioni convenzionali), fino al 2007, con la circolare 44/2008 (retribuzioni convenzionali 2008), ha per la prima volta esplicitamente fornito il seguente parere su taluni casi particolari: “Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi etc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultra- mensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere a una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso, secondo le istruzioni che saranno fornite con la consueta circolare di fine anno”. A tal punto, si è dunque registrata una sorta di discrepanza tra l’interpretazione fornita dal Ministero in ambito tributario e quest’ultima espressa dall’ente previdenziale. A parere di chi scrive, considerato che la seconda è successiva e, soprattutto, che il comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR richiama espressamente il DM ma non ha mai disciplinato nel corso degli anni i criteri della determinazione della retribuzione convenzionale (viceversa, previsti e determinati dall’INPS nel 2008), detta ultima interpretazione potrebbe dover avere effetto anche ai fini fiscali.
Tornando ora ad analizzare l’aspetto tributario, in caso di doppia imposizione sul medesimo reddito, al fine di evitarla (almeno parzialmente), il legislatore ha previsto il meccanismo del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, contenuto nell’art. 165 del TUIR, di cui abbiamo in precedenza accennato, ed è intervenuto con una norma d’interpretazione autentica (decreto legge 223/2006) stabilendo che le disposizioni di cui al comma 10 dell’art. 165 del TUIR devono intendersi riferite anche ai crediti d’imposta per i redditi di lavoro dipendente prodotto all’estero, ex art. 51, comma 8 bis (ovvero, tassati in Italia sulla base della retribuzione convenzionale). Di conseguenza, è possibile portare in diminuzione dalle imposte italiane determinate sulla retribuzione convenzionale, le imposte pagate all’estero; beninteso, sempre in proporzione al reddito tassato in Italia (ossia, entro l’ammontare complessivo della corrispondente imposta dovuta in Italia).
Detto ciò, si rammenta che l’art. 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” ha apportato alcune modifiche alla menzionata disposizione del TUIR. Fin nel testo previgente, la norma precisava che il credito d’imposta spettava soltanto per imposte pagate all’estero “a titolo definitivo”. Tali sono quei tributi divenuti “irripetibili”; nel senso che non devono più essere suscettibili di modifiche a favore del contribuente, né di eventuali rimborsi. Conseguentemente, non possono considerarsi definitive le imposte pagate in acconto, in via provvisoria, o quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso. La detrazione, ovviamente, poi, non spetta nei casi di omessa dichiarazione, o comunque di omessa indicazione del reddito estero. Peraltro, nella situazione ante d.lgs. 147/2015, il credito poteva es- sere indicato solo nella dichiarazione dei redditi italiana relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere erano state pagate in maniera definitiva. Ciò spesso comportava uno sfasamento temporale tra la dichiarazione del reddito in questione e la possibilità di godere del relativo credito d’imposta. Ebbene, il citato articolo 15 del decreto in questione modifica il regime del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, al fine di eliminare le disparità di trattamento presenti nel sistema, estendendo a tutti i contribuenti il regime di detraibilità per competenza, e di riporto avanti e indietro delle eccedenze di tali crediti, di cui prima beneficiavano i soli soggetti passivi imprenditori, purché le medesime imposte estere risultino essere state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo (ossia, un anno in più). La disposi- zione specifica, altresì, che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra I’ Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell’imponibile è prodotto, sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Infine, nel caso in cui dovessero sussistere obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette convenzioni, il contribuente potrà inoltrare all’Amministrazione finanziaria apposita istanza d’interpello.
Abbiamo citato la normativa convenzionale, dunque, prima di concludere forniamo alcune brevi precisazioni al riguardo. Quasi tutte le convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia (perlomeno, quelle con i principali Paesi partner di interesse), sono strutturate secondo il Modello OCSE. L’art. 23 di tale documento stabilisce i due metodi (23.A: metodo dell’esenzione; 23.B: metodo del credito) attraverso i quali la doppia imposizione può essere eliminata. Secondo il primo (esenzione), la disposizione stabilisce che:
- quando un residente di un Paese Contraente percepisca un reddito che deve essere tassato nell’altro Paese Contraente, il primo Paese deve esentare tale reddito dalla tassazione;
- quando un residente di un Paese Contraente acquisisca beni suscettibili di produrre reddito che devono essere tassati nell’altro Paese Contraente, il primo Paese deve consentire la deduzione dall’imposizione sul reddito di quel residente di un ammontare pari alle imposte pagate nell’altro Paese; tale deduzione non deve, tuttavia, eccedere quella parte di imposte che è attribuibile a tali beni derivati dall’altro Paese;
- quando il reddito realizzato da un residente di un Paese Contraente sia esentato dall’imposizione in quel Paese, tale Paese deve comunque, nel calcolo delle imposte sul reddito residuo di detto residente, tenere in considerazione il reddito Con riferimento, al metodo del credito, l’art. 23.B, afferma che:
1.Quando il residente di un Paese Contraente realizza del reddito che deve essere tassato nell’altro Paese Contraente, il primo Paese menzionato deve consentire la deduzione dalle imposte sul reddito di tale residente, per un ammontare pari alle imposte sul reddito pagate nell’altro Paese; questa deduzione in ogni caso non deve eccedere la parte di imposte che è attribuibile al reddito che deve essere tassato nell’altro Paese;
2.Quando il reddito realizzato da un residente di un Paese Contraente venga esentato dalla tassazione in quel Paese, tale Paese deve comunque tenere in considerazione il reddito esentato.
In appendice di elaborato, diamo uno sguardo alla controversa previsione di cui al comma 2-bis dell’art. 2 del TUIR, con- cernente la determinazione dell’effettiva residenza fiscale nelle ipotesi di svolgimento dell’attività nei c. d. paradisi fiscali (seppure, tale termine, è oramai divenuto obsoleto): “Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.” Come facilmente comprensibile, avuto riguardo alla locuzione introdotta dal legislatore “salvo prova contraria”, l’argomento è di quelli che si presta a essere variamente interpretato e che risulta essere motivo di numerosi contenziosi, considerato che l’accertamento dei requisiti per la qualificazione dei soggetti fiscalmente residenti in Italia è questione di mero fatto che può essere risolta dall’Amministrazione finanziaria solo in sede di accertamento e non di interpello interpretativo.
Senza pretesa di entrare in questa sede nello specifico (il tema necessiterebbe di apposito approfondimento), ci pare esemplificativo sul punto riportare una recente sentenza particolarmente significativa: la Cassaz. 6501 del 31.03.2015. In tale pronunciamento, gli ermellini affermano un importante principio che viene spesso disatteso dall’Agenzia delle Entrate nei suoi avvisi di accertamento.
I criteri per la determinazione della residenza fi- scale delle persone fisiche sono dettati dall’articolo 2 del DPR 917/1986, il quale stabilisce come, ai fini delle imposte sui redditi, si considerino resi- denti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta si trovino in una delle seguenti condizioni (tra loro alternative):
- siano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- abbiano la residenza nel territorio dello Stato;
- abbiano il domicilio nel territorio dello Stato, ai sensi del codice civile.
Il comma 2 bis dell’articolo 2 del TUIR dispone che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze. Tale norma prevede una presunzione relativa di residenza per i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza o il proprio domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata. Al fine di essere esclusi dal novero dei soggetti residenti in Italia, ricade dunque su di essi l’onere di provare di risiedere effettivamente in quei Paesi o territori. In altri termini: avere la sede principale dell’attività, sicché il centro degli interessi vitali del soggetto, va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (Cassaz. 18 novembre 2011, n. 24246; Cassaz.15 giugno 2010, n. 14434). Mentre le relazioni affettive e familiari non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto abbia il più stretto collegamento (Cassaz. 24246/2011 cit.; Cassaz. 1 novembre 2001, n. 13803).
A parere dei Giudici di piazza Cavour, dunque, la presunzione (agli effetti fiscali) della residenza italiana dei cittadini trasferitisi in Paesi aventi un regime tributario privilegiato, sostenuta sul mero rilievo della permanenza in Italia delle proprie relazioni affettive e familiari, non ha alcuna valenza laddove il contribuente sia in grado di fornire la prova contraria concernente l’effettività della sua residenza all’estero, durante la maggior parte del periodo d’imposta. Non solo: è la nazione in cui si trova il centro dei propri affari giuridici ed economici a prevalere (quanto all’attribuzione della residenza – anche fiscale), rispetto al fatto che permangano in Italia le relazioni affettive e familiari, le quali ultime assumono – nei confronti del prioritario elemento “economico” – un grado di importanza minore e non possono costituire indizio definitivo se non corroborato da altri criteri probatori. In questo caso, la Suprema Corte ha chiaramente espresso un basilare principio interpretativo della norma. Peraltro, esistono svariate situazioni nella quali le decisioni appaiono particolarmente difficili e aleatorie, implementando notevolmente il numero delle liti. Per deflaziona- re il contenzioso, a parere di chi scrive, sarebbe dunque auspicabile l’introduzione di strumenti, quanto meno, volti a prevenire l’insorgere di contestazioni, conferendo al diritto tributario quell’agognata certezza che, vanamente, si va cercando da tempo e che, anziché apparire più vicina, sembra si stia allontanando sempre di più.
* Odcec Cagliari

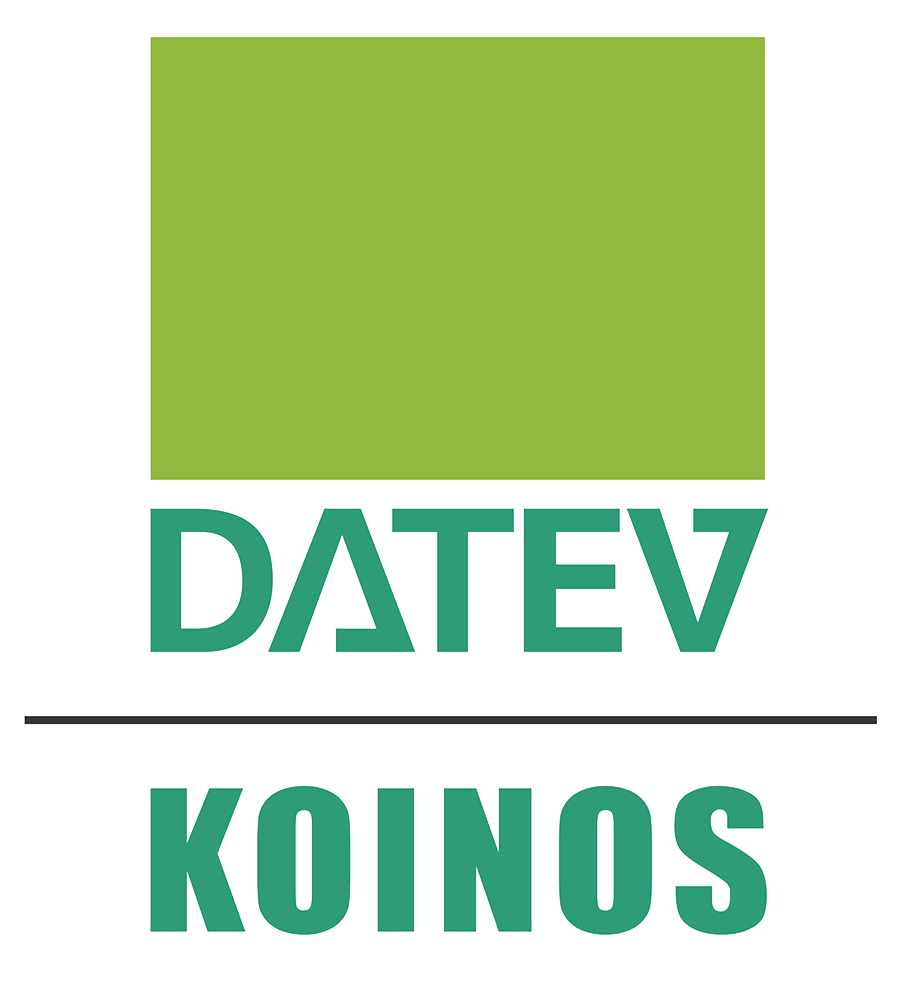






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!