Rassegna di Giurisprudenza
di Bernardina Calafiori*
Cass. Civ. Sez. lav., 6 novembre 2014, n. 23669
Estinzione e risoluzione del rapporto di lavoro subordinato – Licenziamento – Insussistenza del “fatto materiale” – Il- legittimità – Reintegrazione.
Il nuovo art. 18 ha tenuto distinta, invero, dal fatto materiale la sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo, sicché occorre operare una distinzione tra l’esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione. La reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si risolve e si esaurisce nell’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato (nel caso di specie è stata disposta la reintegrazione del lavoratore direttore di banca accusato di condotte inadempienti nella gestione dell’ufficio, atteso che l’istruttoria svolta aveva escluso la commissione delle condotte come contestate, ossia con riferimento ai connotati dell’abitualità che le rendevano più gravi rispetto ad una condotta occasionale, e perciò inidonee a giustificare la massima sanzione disciplinare).
Il caso deciso dalla Suprema Corte riguardava un Direttore di Filiale di un istituto di credito al quale erano state contestate condotte consistenti nell’incaricare abitualmente i dipendenti della filiale di fare la spesa per il direttore durante l’orario di lavoro e di timbrare l’entrata in servizio a nome dello stesso, nell’incaricare ripetutamente il personale di acquistare il pesce in un Comune vicino durante l’orario di lavoro e nell’avere fornito ad un addetto della filiale password e chiavi di accesso alla filiale. Nella motivazione si legge che la contestazione disciplinare si riferiva all’abitualità delle condotte, ossia ave- va riguardo ad un “modus operandi” del di- rettore che denotava un atteggiamento per- durante di grave scorrettezza ed inadempienza nella gestione dell’ufficio.
In fase di reclamo, ritenuto che l’istruttoria svolta avesse escluso le condotte come contestate e ritenuto che i testi escussi non avessero confermato l’abitualità delle stesse, veniva ritenuta l’insussistenza del fatto contestato, con conseguente dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato e condanna del datore di lavoro alla reintegra- zione ex. art. 18, comma 4, S.L, come novellato dalla legge n. 92/2012.
Avverso tale decisione la Banca proponeva ricorso per Cassazione adducendo, tra gli altri numerosi motivi di ricorso, la violazione dell’art. 18, comma 4 e comma 5, ed osservando che “il giudice, accertata l’insussistenza totale ed assoluta del fatto contestato, avrebbe potuto rilevare quanto meno la sussistenza parziale del fatto che giustificava la condanna all’indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità”.
La Corte ha respinto il ricorso, formulando il principio riportato nella massima in epigrafe ed affermando che ai sensi della disciplina di cui alla art. 18, comma 4, S.L. spetta alla lavoratore la reintegrazione nel posto di lavoro in tutte le ipotesi di insussistenza del “fatto materiale” oggetto di contestazione, precisando – a quanto consta per la prima volta – che la verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento si esaurisce nell’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, “con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione”.
Si tratta ovviamente di principio generale applicabile in tuti i settori e non solo in quello bancario.
Interessante è notare la probabile influenza della pronuncia in esame sulla formulazione dello Schema di decreto legislativo approvato dal Governo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (cd. Jobs Act), che all’art. 3 prevede – in maniera non dissimile da quanto precisato dalla sentenza in epigrafe – che “nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione” (oltre che al pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, fino ad un massimo di 12 mensilità).
Cass. Civ. Sez. lav., 27 gennaio 2015, n. 1476
Falso lavoratore autonomo – Iscrizione e pagamento contributi per lavoro auto- nomo – Accertamento natura subordinata del rapporto – Sanzioni civili – Omissioni contributiva – Sussiste
Nel vigore della legge n. 662/96, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, il datore di lavoro che abbia denunciato il rapporto di lavoro quale autonomo, così come qualificato dalle parti, e abbia provveduto al versamento dei contributi al relativo ente previdenziale, deve pagare, in caso di obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede amministrativa o giudiziali, le sanzioni civili per omissione ai sensi dell’art. 1, comma 217, lettera a), della suddetta legge e non già per evasione contributiva.
Il caso riguardava un rapporto di lavoro autonomo instaurato con un geometra. Il committente provvedeva a denunciare il rapporto ed al versamento dei contributi alla Cassa geometri.
Successivamente veniva accertata la natura subordinata del rapporto, e l’INPS provvedeva al recupero dei contributi non pagati, applicando le sanzioni civili previste per l’ipotesi di evasione contributiva.
I giudici di merito confermavano la sussistenza di un’ipotesi di evasione e quindi l’applicabilità delle più gravi sanzioni civili previste per tale ipotesi (in luogo delle meno gravose sanzioni previste per il caso di omissione contributiva).
Contro la decisione dei giudici di merito, il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione, affermando che l’avvenuta denuncia del rapporto di lavoro autonomo ed il pagamento dei relativi contributi escludesse in radice la volontà di occultare il rapporto di lavoro e quindi la configurabilità della più grave ipotesi di evasione.
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo configurata nella specie la meno grave ipotesi di omissione. Nella motivazione viene evidenziato che le parti avevano qualificato come autonomo il rapporto e come tale lo stesso era stato regolarmente denunciato ai fini previdenziali. La Corte afferma chiaramente che in tale ipotesi il datore di lavoro non ha altra alternativa se non quella della denunzia del rapporto così come qualificato dalle parti. Nell’ipotesi in cui a seguito di un’ispezione o in via giudiziale venga accertata la diversa natura subordinata del rap- porto, se il preteso rapporto di lavoro auto- nomo era stato previamente denunciato ed i relativi contributi previdenziali pagati, il datore di lavoro resta soggetto alle sanzioni civili per omissione (e non alle più gravi sanzioni previste per l’ipotesi di evasione).
Cass. Civ. Sez. lav., 11 febbraio 2015, n. 2679
Sicurezza nei luoghi di lavoro – Lavora- tori addetti a videoterminali – Diritto all’interruzione dell’attività mediante pause ovvero mediante adibizione a mansioni diverse
Ai fini della normativa di sicurezza in materia di videoterminalisti lo svolgimento, seppure in misura minore, di attività amministrativa nella stessa giornata comporta un cambiamento di attività idonea ad integrare l’interruzione prevista dalla legge a tutela del lavoratore. Non è rilevante il carattere prevalente, nell’arco della giornata lavorativa, dell’adibizione al videoterminale, bensì soltanto la continuità della stessa.
Come noto la normativa vigente (v. art. 175 del D.Lgs. n. 81/2008) prevede che il lavoratore addetto a videoterminale abbia diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva e, anche in assenza di una specifica disposizione contrattuale, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Il caso deciso riguardava una lavoratrice che aveva chiesto ed ottenuto, con sentenza favorevole in primo grado, il risarcimento del danno per mancata fruizione delle pause al videoterminale.
I giudici di appello hanno riformato la sentenza di primo grado, rilevando che dalla prova testimoniale era emerso lo svolgimento di altre autonome mansioni amministrati- ve che non comportavano l’uso continuativo di videoterminali. Tale cambiamento di attività, secondo i giudici di appello, realizzava la condizione del cambiamento di mansione prevista dal legislatore in alternativa al regime regolamentato delle pause.
In particolare veniva evidenziato che, pur essendo innegabile che anche per lo svolgimento di tale diversa attività amministrativa era “funzionalmente connessa all’uso dei videoterminali” (essendo comunque inevitabile il ricorso al videoterminale anche per lo svolgimento di tale “diversa” attività), il tutto avveniva in maniera discontinua (ad esempio anche attraverso la consultazione di pratiche cartacee) e che, quindi, ai fini della configurabilità del richiesto danno per mancata fruizione delle pause, difettava l’immancabile requisito della “continuità” dell’adibizione a video terminale.
Il tutto anche se era stato accertato che l’uso continuativo in linea del videoterminale copriva all’incirca il 60% dell’attività svolta nella giornata lavorativa.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha confermato la decisione di giudici di appello, chiarendo che non è in difetto il datore di lavoro che in luogo delle pause regolamentate adibisca il lavoratore a mansioni diverse, intendendosi per tali anche quelle che comportino un uso discontinuo del videoterminale.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, requisito essenziale per il diritto alla fruizione delle pause non è tanto la prevalenza dell’attività svolta a videoterminale, ma a rilevare è soltanto la continuità della stessa. Il diritto al risarcimento del danno per mancata fruizione delle pause quindi sorge solo in caso di adibizione continuativa (a prescindere dalla prevalenza o meno di tale adibizione), ben potendo invece intendersi rispettata la misura di tutela imposta dal legislatore anche dall’adibizione a mansioni diverse, e anche ove le stesse comportino un uso solo discontinuo del videoterminale.
Cass. Civ. Sez. lav., 20 marzo 2015, n. 5717
Estinzione e risoluzione del rapporto di lavoro subordinato – Licenziamento – Termini per l’impugnazione
La lettera della disposizione contenuta nell’art. 32, comma 1, legge n. 183 del 2010, modificato dall’art. 1, comma 38, legge n. 92 del 2012 che commina l’inefficacia “dell’impugnazione” extragiudiziale non seguita da tempestiva azione giudiziale, dimostra come dal primo dei due atti debba decorrere il termine per compiere il secondo, e non dalla fine dei sessanta giorni concessi per l’impugnazione stragiudiziale. L’esigenza di celerità, intesa a tutelare l’interesse del datore di lavoro alla certezza del rapporto, indica ancora che il termine debba decorrere dalla spedizione e non dalla ricezione dell’atto.
Come noto, nel regime anteriore al cd. Col- legato Lavoro (legge n. 183/2010), il lavoratore licenziato, che aveva tempestivamente impugnato il licenziamento in via stragiudiziale nel termine di 60 giorni, poteva poi proporre l’impugnazione giudiziale nel termine quinquennale di prescrizione.
Tale temine era stato sottoposto negli anni più recenti a costanti critiche, ritenendo che lo stesso favorisse il permanere di una situazione di incertezza giuridica particolarmente gravosa per il datore di lavoro, considerato il rischio per quest’ultimo di vedersi condannare alla reintegrazione e al risarcimento del danno, che aumentava con il trascorrere del tempo.
Sul punto è intervenuto il Collegato Lavoro, stabilendo che l’impugnazione stragiudiziale (comunque da proporsi nel termine di 60 giorni dall’intimazione del licenziamento) diviene inefficace se non è seguita dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione del giudice del lavoro entro il successivo termine di 270 giorni. Come noto quest’ultimo termine è stato poi ulteriormente ridotto a 180 giorni, con le modifiche apportate nel 2012 dalla cd. legge Fornero (legge n. 92/2012).
In sede di applicazione delle nuove disposi- zioni è insorto contrasto giurisprudenziale sul dies a quo dal quale far decorrere il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso e l’impugnazione giudiziale.
Secondo un primo orientamento dei giudici di merito – più coerente con la ratio di celerità e di certezza dei rapporti giuridici che ispirava le nuove disposizioni – il termine di 180 giorni doveva decorrere dalla data di spedizione dell’impugnazione stragiudiziale (si vedano, ex plurimis, Tribunale di Torino, 19 febbraio 2013; Tribunale di Milano, 3 dicembre 2013).
Secondo altro orientamento giurisprudenziale, a quanto consta minoritario, dovrebbe aversi riguardo all’intera durata del termine di sessanta giorni e, a prescindere dalla data di spedizione dell’impugnativa stragiudiziale, il termine per il ricorso giudiziale decorrerebbe comunque dallo spirare del sessante- simo giorno (v. Tribunale di Teramo, 23 luglio 2014).
In tal senso e secondo tale ultimo orienta- mento avevano deciso anche i giudici di appello nella causa ora decisa dalla Suprema Corte con la sentenza indicata in epigrafe.
La Corte di Cassazione, pronunciandosi per la prima volta sul punto, ha cassato la sen- tenza di appello impugnata dal datore di la- voro, affermando il principio secondo il quale il termine per l’impugnazione giudiziale del licenziamento decorre dalla data dell’impugnazione stragiudiziale dello stesso (e non quindi decorsi i 60 giorni) e che tale termine debba decorrere dalla data di spedi- zione dell’impugnazione (e non di ricezione dell’atto). E ciò sulla base dell’esigenza di celerità sottesa dalla norma in questione, a tutela dell’interesse del datore di lavoro alla certezza dei rapporti giuridici.
Non è escluso che, data la rilevanza della questione, il caso possa successivamente pervenire al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte (in caso di pronuncia dif- forme da parte di altra Sezione semplice).
*Socio Fondatore Studio Legale Daverio & Florio

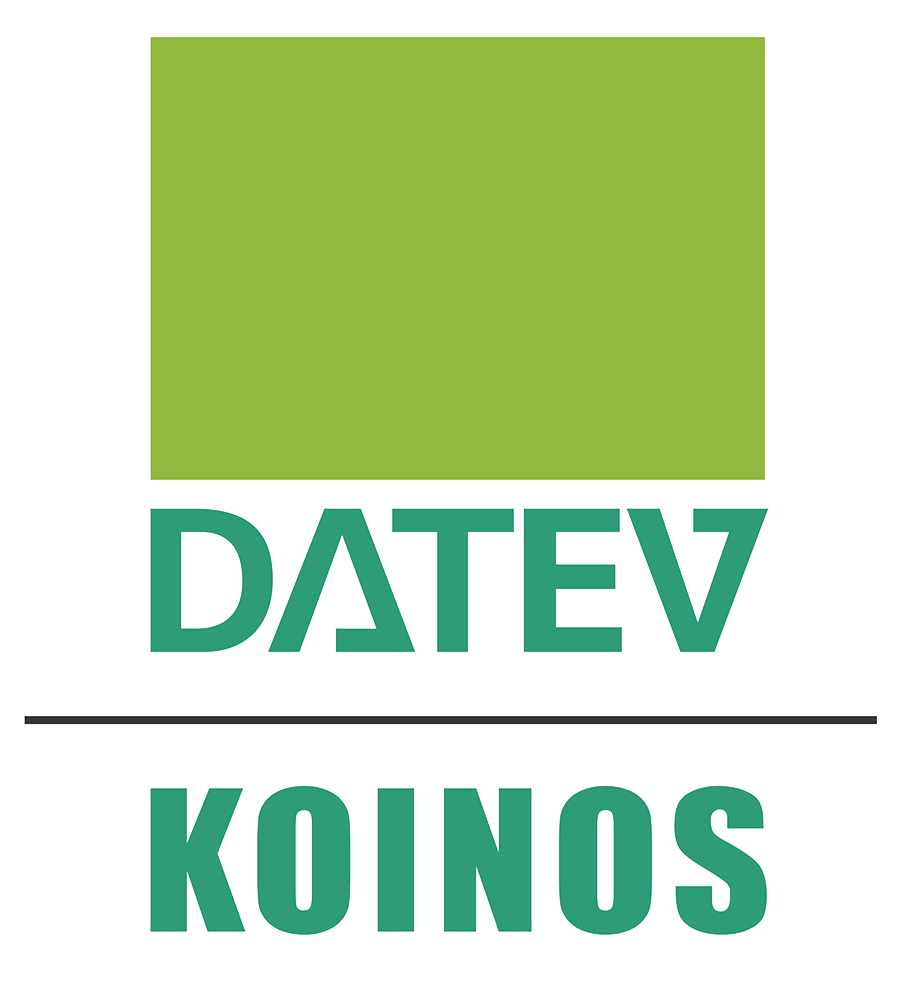






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!