Un popolo di coraggiosi
di Maurizio Centra*
A Roma tra i tanti edifici monumentali ce n’è uno chiamato Palazzo della Civiltà Italiana o anche Palazzo della Civiltà e del Lavoro, rinominato dalla fantasia popolare Colosseo quadrato per le sue caratteristiche architettoniche, che per molti anni è rimasto in aulica disparte rispetto alla vita della nazione, anche se questo non gli ha impedito di ottenere dal ministero per i Beni e le Attività Culturali il riconoscimento di bene di interesse culturale, ai sensi del decreto legislativo 42/2004.
La storia di questo edificio inizia negli anni ’30 del secolo scorso quando il Governo dell’epoca, in previsione della Esposizione Universale di Roma del 1942, che non si realizzò a causa della guerra, avviò l’urbanizzazione della Città di Roma in direzione sud, l’ungo l’asse viaria che porta al Mar Tirreno (Lido di Ostia), e la costruzione di un nuovo quartiere (Eur), dove esisteva un’estesa pianura facile da coltivare. Sotto la presidenza dell’Arch. Marcello Piacentini, esponente di spicco del monumentalismo italiano durante il Ventennio, la commissione esaminatrice scelse il progetto di Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula e Mario Romano di un palazzo di forma sostanzialmente cubica con quattro facciate caratterizzate dalla presenza di archi, da qui l’appellativo di Colosseo quadrato. In realtà il progetto originale prevedeva una struttura più grande di quella realizzata, composta di 77 archi per facciata (11 in lunghezza e 7 in altezza), che sono stati ridotti a 54 (9 in lunghezza e 6 in altezza) per ragioni economiche, potremmo dire di spending review… ante litteram. Ciò nonostante, il palazzo non ne ha risentito molto, tanto da diventare uno dei più conosciuti simboli di Roma di età contemporanea, con la sua impeccabile livrea di travertino banco.
In cima al Palazzo della Civiltà Italiana, sulle quattro testate, all’incirca a 60 metri da terra, campeggia l’incisione: “Un popolo di poeti di artisti di eroi / di santi di pensatori di scienziati / di navigatori di trasmigratori”, riferendosi, ovviamente al popolo italiano. Visto il periodo storico nel quale è stato progettato, non c’è da stupirsi della retorica che caratterizza questa frase, anche se non può certo negarsi che di italiani artisti, eroi, scienziati e quant’altro ce ne siano stati, ce ne sono e ce ne saranno in futuro moltissimi, ma tra tutte le italiche qualità scolpite nella pietra quasi ottanta anni fa (i lavori di costruzione iniziarono nel luglio del 1938) ne manca sicuramente una: un popolo di donne e uomini coraggiosi!
In Europa sono molti i popoli che hanno dimostrato grande coraggio, basti pensare alle numerose forme di resistenza ai regimi totalitari del XX secolo, come il nazismo, ma è innegabile che gli italiani abbiano dimostrato coraggio ripetutamente e nelle situazioni più diverse. Quale popolo avrebbe saputo reagire alla fuga del proprio sovrano, ossia di Vittorio Emanuele III “per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d’Italia”, che all’alba del 9 settembre 1943 – nel bel mezzo della più sanguinosa guerra che l’umanità ricordi – abbandonò Roma e il suo posto cercando la salvezza a Brindisi, lasciando senza ordini l’esercito e gli apparati dello Stato dopo la firma dell’Armistizio di Cassibile, avvenuta il 3 settembre 1943 ma diffusa il successivo 8 settembre (proclama di Badoglio). Chi avrebbe saputo gestire in quei momenti concitati e dolorosi i rapporti con i tedeschi, diventati nemici da un giorno all’altro ma presenti militarmente su gran parte del nostro territorio, sopportando rappresaglie di inimmaginabile crudeltà, basti ricordare l’eccidio delle Fosse Ardeatine (24 marzo 1944) e le numerose operazioni di giustizia sommaria, veri e propri atti di crudeltà senza pari compiuti sulla popolazione civile? Chi avrebbe saputo salvare dalla morte uomini e donne colpevoli solo di professare la religione ebraica mettendo a rischio la propria stessa vita? Quanti di noi hanno ascoltato dai propri nonni i racconti di azioni di eroismo domestico compiute senza “pensarci su troppo”. Per non parlare degli atti di coraggio individuale passati alla storia, come quello del carabiniere Salvo D’Acquisto che il 23 settembre 1943 ha sacrificato la propria vita per salvare quella di un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste alla periferia di Roma e che per la sua azione è stato insignito della Medaglia d›oro al valor militare alla memoria. A questo italiano coraggioso, che è stato oggetto di un processo canonico di beatificazione da parte della Chiesa cattolica, concluso il 25 novembre 1991 con la trasmissione degli atti alla Congregazione delle Cause dei Santi, è attribuita la frase “Se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte: Dio è con me e io non ho paura!”
Ma il coraggio del popolo italiano non si è manifestato solo nel tragico periodo della seconda guerra mondiale, ha caratterizzato l’azione sia individuale sia collettiva fin dall’unità d’Italia (1861), non solo con atti di eclatante eroismo ma anche con il sacrificio silente dei tanti che sono emigrati per cercare un lavoro che li affrancasse dalla povertà. Lasciare il proprio Paese, la famiglia e gli affetti richiede coraggio, anche quando si è spinti da bisogni primari, e ancor più coraggio occorre per rimanere ligi ai propri valori di onestà e rettitudine in terra straniera, quando si viene trattati “senza tanti complimenti”. Si stima che solo nei primi 15 anni dall’unità d’Italia siano emigrati oltre 10 milioni di connazionali che sono più che raddoppiati negli anni successivi.
E’ appena il caso di ricordare che il fenomeno migratorio in Italia si è sviluppato in due periodi, nel primo, cha va dalla fine del XIX secolo e gli anni trenta del XX secolo, la meta principale è stata l’America, nel secondo, che è iniziato negli anni cinquanta del XX secolo ed è durato una ventina d’anni, le mete sono state prevalentemente i paesi del nord Europa (Belgio, Germania, Francia, ecc.). Oggi è difficile immaginare quanto fosse diffusa la povertà in Italia all’inizio del XX secolo, anche a causa di un’economia prevalentemente agricola, e come il fenomeno migratorio abbia favorito la pace sociale, impedendo le sommosse degli indigenti, che erano tanti, e contribuendo al sostentamento dei residenti, grazie alle rimesse economiche degli emigrati; effetti avvertiti su quasi tutto il Paese perché l’emigrazione è stato un fenomeno trasversale, nel senso che tra il 1876 e il 1900 ha riguardato in massima parte le regioni del nord, quali il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte, mentre nei decenni successivi le regioni meridionali, quali la Calabria, la Campania, la Puglia e la Sicilia.
L’Italia vanta il triste primato del paese europeo con il più alto flusso migratorio della storia contemporanea e in ogni parte del mondo i nostri connazionali hanno dovuto far ricorso a tutto il loro coraggio per superare non solo ostilità e pregiudizi, ma anche prove di idoneità fisica e accertamenti sanitari analoghi a quelli degli animali destinati al macello. Per averne un’idea è sufficiente visitare il Museo dell’immigrazione di Ellis Island che nel 1990 è stato istituito là dove fino al 1954 i medici del Servizio Immigrazione degli stati Uniti d’America (USA) controllavano gli immigrati prima che mettessero piede sul suolo statunitense, “marcando” con un gesso sulla schiena quelli che dovevano essere sottoposti a ulteriori controlli e respingendo immediatamente “i vecchi, i deformi, i ciechi, i sordomuti e tutti coloro che soffrono di malattie contagiose, aberrazioni mentali e qualsiasi altra infermità …”, che venivano reimbarcati sulla stessa nave con la quale erano arrivati, la quale aveva l’obbligo di riportarli al porto di provenienza, in base alla legislazione USA.
Il coraggio dunque, non solo di lasciarsi tutto alle spalle ma anche di mettersi a nudo, non solo in senso metaforico, per dimostrare di poter lavorare manualmente, qualunque fosse il proprio livello di istruzione. Analogo se non maggior coraggio hanno dimostrato gli italiani emigrati nel secondo periodo, che in paesi territorialmente e culturalmente più vicini al nostro, come il Belgio, la Germania o la Svizzera, hanno dovuto subire anche ingiurie e violenze xenofobe. Fenomeno che, purtroppo, non si è verificato solo all’estero ma negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso anche in alcune città del nord Italia nei confronti dei connazionali provenienti dalle regioni del sud.
La crisi economica iniziata nel 2008 ha riproposto nel nostro Paese il problema della disoccupazione, in termini non paragonabili a quelli delle migrazioni, ma tali da creare tensioni collettive e drammi familiari non trascurabili. I giovani stentano a trovare un’occupazione stabile e remunerata in maniera tale da consentire loro una vita libera e dignitosa, come prevede l’art. 36 della costituzione “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa …”, ed è il coraggio delle famiglie alle quali appartengono che sta salvaguardando il nostro sistema sociale, in evidente difficoltà. Ma se i giovani possono considerare la mancanza di un’occupazione come un rallentamento nel lungo percorso di vita che li attende, sono i disoccupati ultra cinquantenni che stanno dimostrando un coraggio fuori dal comune, emarginati dopo 25 o 30 anni di lavoro, spesso trascorsi nella stessa impresa o nello stesso settore, troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per essere adibiti a nuove mansioni, entrati nel mondo del lavoro quando bastava leggere gli annunci economici, il più delle volte con il mutuo da pagare e i figli ancora a carico, sono un piccolo esercito di dignitosi personaggi in cerca di autore pronti a qualunque riconversione professionale pur di “tornare in pista” e sottrarsi alla sgradevole sensazione di inutilità sociale e familiare. Al coraggio di costoro dovremmo ispirarci quando le difficoltà del lavoro ci sembrano insormontabili.
Proseguendo idealmente il percorso suggerito dall’incisione sulla testata del Palazzo della Civiltà Italiana (Un popolo di poeti di artisti di eroi …) e dalla sua “parte mancante”, sorge spontaneo ricordare anche il coraggio dimostrato da molti dei nostri più illustri scienziati, in realtà anche dai santi, come il patrono d’Italia Francesco d’Assisi, che nel 1206 ha abbandonato le sue ricchezze e gli agi del ceto sociale al quale apparteneva per dedicarsi in estrema povertà all’aiuto dei più bisognosi, ma non è oggetto di questo articolo. Tra gli scienziati emblematico è il coraggio dimostrato da Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la medicina nel 1986. Nata a Torino nel 1909 da una famiglia ebrea benestante non trovò nel padre, uomo austero, un aiuto per i suoi studi di medicina, ciò nonostante si iscrisse all’Università di Torino dove si laureò nel 1936 in medicina e chirurgia con il massimo dei voti. Poco dopo le leggi razziali (1938) imposero alla scienziata di emigrare in Belgio, dove rimase fino all’invasione tedesca della primavera del 1940 e riuscì a proseguire gli studi sul sistema nervoso, iniziati subito dopo la laurea. Nell’inverno del 1940 tornò in Italia e, sfidando i divieti dell’epoca, riprese i suoi studi in un laboratorio di fortuna realizzato in casa, prima a Torino, poi nelle campagne dell’astigiano quindi, in condizioni sempre più precarie, presso le case di amici e conoscenti che la ospitarono, assieme ai suoi familiari, in varie zone del centro Italia. Nell’agosto 1944, quando le sorti della guerra sembravano segnate, la Montalcini divenne medico presso il Quartier Generale anglo-americano di Firenze occupandosi di epidemie di malattie infettive e di tifo addominale. Finita la guerra, riprese a Torino i suoi studi sullo sviluppo dei neuroni isolati da vari elementi del tessuto cerebrale dell’embrione e, pur non avendo a disposizione strumenti sofisticati, ottenne risultati sorprendenti, che vennero pubblicati sulle più prestigiose riviste scientifiche internazionali. Il resto è storia relativamente recente, la scienziata venne invitata dalla Washington University di St. Louis nello stato di Missouri (USA) dove, dopo aver presentato nel dicembre del 1951 la sua tesi presso la New York Academy of Sciences, proseguì i suoi studi e si dedicò all’insegnamento fino al 1977. Nei trent’anni circa trascorsi negli USA, la Montalcini, non ha mai reciso il cordone ombelicale con il suo Paese, tutt’altro, ha fondato e diretto un gruppo di ricerche in Italia e ricoperto, dal 1961 al 1979, incarichi di crescente rilevanza scientifica presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Innumerevoli sono le prove della sua determinazione, del coraggio e della passione con cui ha svolto il suo lavoro fino alla morte, avvenuta nel 2012 all’età di 103 anni, molti anche i riconoscimenti, oltre al Premio Nobel, le onorificenze, le lauree honoris causa e gli incarichi ricoperti nelle maggiori accademie scientifiche internazionali, come l’Accademia Nazionale dei Lincei, la Pontificia Accademia delle Scienze, di cui è stata la prima donna a ottenere l’ammissione, l’Accademia Nazionale delle Scienze, la National Academy of Sciences (USA) e la Royal Society, oltre alla nomina a Senatrice a vita disposta dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, il 1º agosto del 2001. Proviamo a immaginare cosa sarebbe stata Rita Levi Montalcini senza il suo coraggio, sicuramente un buon medico, ma la ricerca scientifica sarebbe progredita di meno o, nella migliore delle ipotesi, più lentamente e forse oggi non sarebbe ancora possibile controllare la crescita dei tumori delle cellule nervose.
Un popolo di donne e uomini coraggiosi è tale anche quando riesce a superare sia le calamità naturali sia le azioni violente organizzate. Per le prime c’è il rammarico che dal terremoto di Messina del 1908 ai giorni nostri l’Italia non sia ancora riuscita a darsi regole e procedure che riducano al minimo i danni delle calamità naturali, anche se nel tempo sono cresciute le forme di solidarietà umana di natura privatistica, che – in ogni caso – non possono sostituirsi alle attività di prevenzione e assistenza proprie dello stato e degli enti pubblici. Per le seconde c’è la consapevolezza che nessuna violenza è destinata a durare nel tempo o rimanere impunita, anche grazie al coraggio di chi non si tira indietro davanti al pericolo. Negli ultimi anni il terrorismo di matrice islamica sta flagellando l’Europa con attentati nei confronti di cittadini civili, impossibili da accettare socialmente e difficili da comprendere militarmente, ma, prima di quello attuale, l’Italia ha vissuto un lungo periodo di attentati terroristici di matrice politica interna che è iniziato alla fine degli anni ’60 del XX secolo e durato circa venti anni, passando alla storia con il termine anni di piombo. Prima e dopo gli anni di piombo, in verità, si sono verificati altri eventi terroristici o di criminalità organizzata assai gravi, ma in quel periodo l’Italia ha subito una serie di attentati, molti dei quali tra loro legati, che hanno fatto parlare di strategia della tensione e di paese sull’orlo di una guerra civile.
Dagli anni di piombo ai giorni nostri sono molti gli italiani che hanno dimostrato grande coraggio, facendo semplicemente il loro dovere, tra questi ricordiamo il commissario di polizia Luigi Calabresi, che il 17 maggio 1972 è rimasto vittima a Milano di un attentato di matrice politica extraparlamentare a causa delle sue indagini, il giornalista Carlo Casalegno, che nel novembre 1977 è stato ucciso dalle Brigate Rosse per aver denunciato l’eversione, le complicità e la finta neutralità fra istituzioni e brigatisti; l’onorevole Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978, per il suo progetto politico che prevedeva forme di collaborazione tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano, tradizionalmente antagonisti, il sindacalista Guido Rossa, che il 24 gennaio 1979 è caduto sotto i colpi delle Brigate Rosse per aver denunciato un infiltrato che diffondeva volantini e comunicati della stessa organizzazione terroristica all’interno dello stabilimento Italsider di Genova; il giornalista Walter Tobagi, scrittore e docente universitario, ucciso a 33 anni il 28 maggio 1980 a Milano, da un gruppo di assassini della Brigata 28 Marzo per i suoi articoli sul terrorismo; il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che dopo aver lottato per anni contro le Brigate Rosse è stato ucciso il 3 settembre 1982 in un attentato di matrice mafiosa, il giornalista Giuseppe (Pippo) Fava, ucciso il 5 gennaio 1984 per aver denunciato collusioni tra mafia, politica e imprenditoria; i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi nel 1992 a 57 giorni di distanza l’uno dall’altro, per il loro impegno contro la mafia; il prof. Massimo D’Antona e il prof. Marco Biagi, entrambi docenti di diritto del lavoro, uccisi dalle Brigate Rosse, rispettivamente il 20 maggio 1999 e il 19 marzo 2002, nel vano tentativo di condizionare l’opinione pubblica e la classe politica, come avvenuto negli anni di piombo.
Ma il coraggio da ricordare è anche quello dei genitori che durante gli anni di piombo hanno fatto vivere i loro figli senza eccessive paure, soprattutto nelle grandi città come Roma e Milano, aumentando le precauzioni ma non impedendogli di condurre una vita sostanzialmente libera e serena.
Quando si parla di coraggio non si può trascurare quello degli sportivi e tra i nostri connazionali ce ne sono tanti che hanno dimostrato di averne. Uno degli atleti che si è distinto fin dalla giovane età per un coraggio senza pari è stato Pietro Mennea, scomparso nel 2013 all’età di sessanta anni, che ha superato le difficoltà di essere nato in una piccola città del sud (Barletta) e di avere un fisico piuttosto esile, rispetto agli atleti della sua specialità, e che ha raggiunto diversi primati mondiali (campione olimpico dei 200 metri piani a Mosca 1980 e primatista mondiale della specialità dal 1979 al 1996 con 19’’72), si è qualificato per quattro finali olimpiche consecutive (dal 1972 al 1984) e laureato per ben quattro volte. Il coraggio di Mennea dimostra che la forza di volontà può fare la differenza e che un campione nello sport può essere un campione anche nella vita, se lo vuole. Non a caso dopo aver “appeso le scarpette al chiodo” Mennea è stato docente universitario, ha svolto attività politica, scritto dei saggi ed esercitato le professioni di avvocato e commercialista.
Il coraggio lo ha dimostrato anche Fabio Grosso nella notte del 9 luglio 2006 a Berlino, quando – dimenticandosi di essere un difensore – si è incaricato di calciare il rigore decisivo per la Nazionale Italiana nella finale dei Mondiali di Calcio di quell’anno e, segnando, ha fatto vincere al nostro Paese il quarto titolo mondiale. Ma non sempre il coraggio da solo è sufficiente, infatti pochi anni prima, a Rose Bowl di Pasadena in California (USA), nella finale della Coppa del Mondo 1994, un giocatore di ben altra levatura tecnica, Roberto Baggio, ha sbagliato un calcio di rigore altrettanto decisivo, pur restando un indiscusso campione. L’importante è credere nei propri mezzi, prepararsi con serietà e affrontare l’impegno, qualunque impegno, con coraggio e lealtà, accettando l’insuccesso in modo decoroso e imparando dall’errore per migliorare, e ricordando, perché no, le parole di Francesco De Gregori: “… Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore, un giocatore lo vedi dal coraggio dall’altruismo e dalla fantasia” (Leva calcistica della classe ’68).
* Odcec Roma

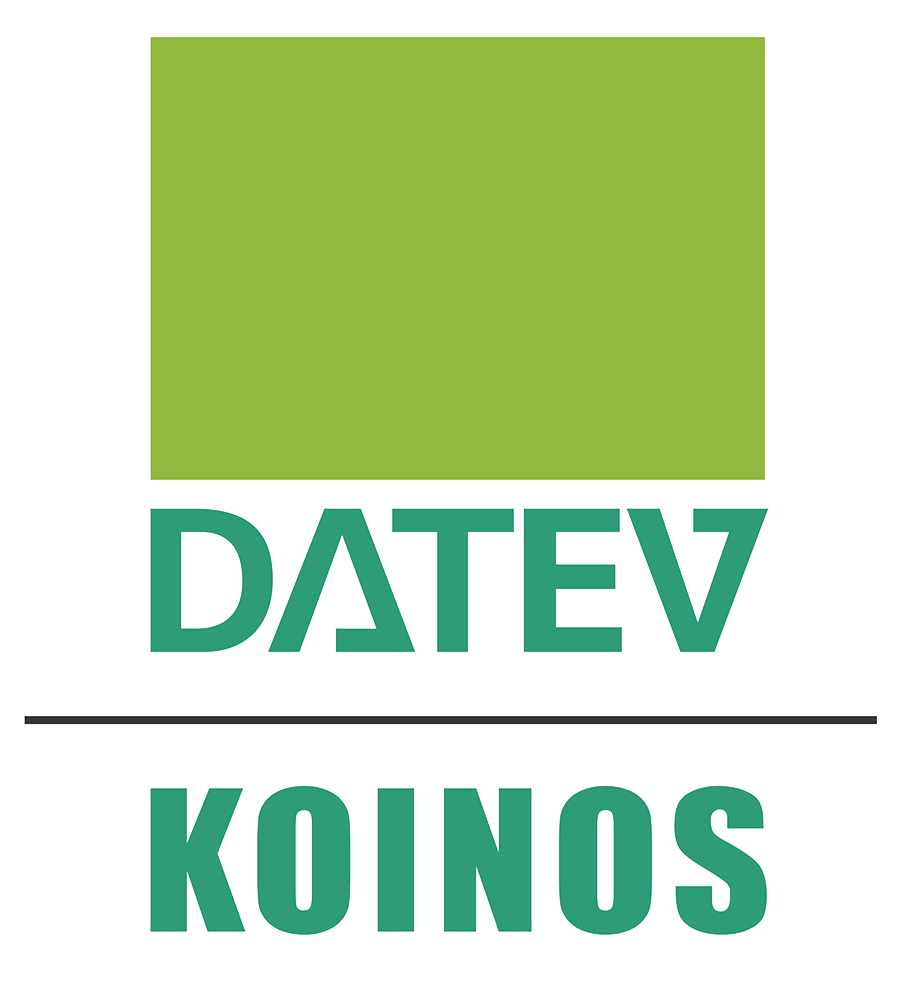






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!