Il Welfare Aziendale nelle imprese di minori dimensioni
di Maurizio Centra*
Dopo la seconda guerra mondiale nell’Europa occidentale si sono affermate le politiche che prevedono l’intervento dello stato nell’economia, in primis per garantire l’assistenza e il benessere dei cittadini. Nel tempo l’assistenza caritatevole è stata sostituita da servizi concepiti secondo logiche di pubblica utilità, ad esempio nell’ambio della sanità, e finanziati dalle imposte sui redditi, in modo tale da incidere anche sulla distribuzione degli stessi redditi e ridurre le disuguaglianze sociali. Non che in precedenza temi come l’assistenza e il benessere dei cittadini fossero del tutto ignorati dalla società, infatti tra la prima (1750) e la seconda (1870) rivoluzione industriale crebbero, soprattutto in Inghilterra, iniziative dei lavoratori tese a ottenere migliori condizioni di vita e di lavoro, che, in alcuni casi, trovarono modeste risposte dai datori di lavoro, ad esempio con l’introduzione del medico di fabbrica, ma che sostanzialmente non modificarono la convinzione all’epoca prevalente tra la classe politica, in base alla quale questi temi non rientravano tra le funzioni dello stato. Dalla seconda metà del 1945, con la ricostruzione dei paesi europei devastati dalla guerra, sono stati quindi introdotti o potenziati gli istituti di assistenza ai cittadini, come l’assistenza sanitaria, la tutela della maternità, le indennità economiche di malattia, infortunio e disoccupazione, gli assegni familiari, le case popolari, ecc., con modalità e tempi diversi da paese a paese, ma con scopi analoghi. In questo periodo è stato anche coniato il termine welfare state, che identifica il complesso di politiche pubbliche dirette a migliorare le condizioni di vita dei cittadini, in un’economia di mercato. Secondo I. Gough il welfare è “l’uso del potere dello Stato volto a favorire l’adattamento della forza lavoro ai continui cambiamenti del mercato e a mantenere la popolazione non lavorativa in una società capitalistica”.
Fino alla crisi energetica degli anni settanta del secolo scorso, la crescita del welfare state è stata costante, per quantità e qualità degli interventi, ma da allora la sua “spinta propulsiva” si è ridotta sensibilmente, a causa della necessità di contenere la spesa pubblica, pur in presenza di nuove esigenze sociali meritevoli di tutela. Così com’è successo nella fase espansiva, anche nella fase di contenimento del welfare state ciascun paese ha adottato un proprio metodo, per cui taluni, come i paesi del nord Europa, sono riusciti a combinare politiche rigorose con tutele di stampo universalistico, mentre altri, tra cui l’Italia, stanno cercando di riequilibrare un sistema mal funzionante, che fornisce coperture costose solo ad alcune categorie di cittadini. In entrambe le soluzioni la “copertura” di alcune tutele è oggi affidata alle politiche aziendali, con interventi comunemente denominati di welfare aziendale. Per questo, con il termine welfare aziendale si intende l’insieme di iniziative che i datori di lavoro attuano a favore dei lavoratori ovvero di alcune categorie di lavoratori, allo scopo di soddisfare talune domande che non trovano o non trovano più una risposta da parte dello stato e/o di enti pubblici, come l’assistenza sanitaria, la cura della famiglia, l’istruzione propria o dei figli, l’accesso al credito, ecc.
La modalità attraverso la quale le politiche di welfare aziendale vengono attuate è – di norma – l’accordo sindacale, per questo il legislatore lo richiede quale presupposto ai fini dell’applicazione di trattamenti tributari e previdenziali di vantaggio alle più diffuse forme di welfare aziendale. Ma le norme vigenti non si “accontentano” di un qualunque accordo sindacale, ma considerano validi, ai fini della agevolazioni, quelli stipulati dalle organizzazionisindacalicomparativamente più rappresentative in ambito nazionale ovvero alle rappresentanze aziendali o alle strutture territoriali delle stesse confederazioni.
Il valore dei fringe benefit, ossia la spesa sostenuta dal datore di lavoro (imprenditore) allo scopo di soddisfare una o più esigenze personali o familiari del lavoratore, costituisce retribuzione in natura, che non concorre a formare il reddito dello stesso lavoratore solo per l’espressa deroga stabilita dalla normativa tributaria, altrimenti entrerebbe a far parte dell’imponibile Irpef in base all’art. 51, primo comma, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n.917 “Testo unico delle imposte sui redditi” (Tuir), il quale dispone che costituiscono redditi di lavoro dipendente “… tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro“ (principio di onnicomprensività).
In realtà il legislatore è stato nei confronti del lavoratore più “clemente” di quanto sia stato nei confronti del datore di lavoro, prevedendo anche delle agevolazioni che non richiedono l’accordo sindacale, si veda l’art. 1, comma 28, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), che ha introdotto all’art. 51, comma 2, del Tuir, la lettera d-bis), la quale stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12”.
Per il datore di lavoro la situazione è diversa, infatti in assenza di una accordo sindacale la spesa sostenuta per erogare fringe benefit ai lavoratori costituisce un onere sostenuto volontariamente e non un obbligo, con la conseguenza di non essere integralmente deducibile, infatti l’art. 100, comma 1, del Tuir stabilisce che “le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”. Come se non fosse chiaro, questo concetto è stato ribadito dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 378/2007, nella quale afferma che le erogazioni di cui alle lettere f) e f bis) dell’art. 51, comma 2, sono integralmente deducibili per il datore di lavoro (imprenditore) ai sensi dell’art. 95 “Spese per prestazioni di lavoro” del Tuir, quando non sono sostenute volontariamente. Sull’argomento l’Agenzia delle entrate è tornata con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 affermando che “la erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del medesimo testo unico. Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro”. Alla fine dello stesso anno anche il legislatore, con l’art. 1, comma 162, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, ha fornito l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art. 51, comma 2, lettera f), del Tuir nel seguente modo: “… si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale”.
L’accordo con la controparte sindacale, sia esso in ambito aziendale, territoriale, interconfederale o nazionale, è dunque per il datore di lavoro il presupposto della piena deducibilità fiscale delle spese sostenute per l’erogazione di fringe benefit ai lavoratori, ma in pratica sono solo i contratti collettivi aziendali a occuparsene in modo esauriente. I contratti collettivi nazionali e quelli interconfederali trattano spesso l’argomento del welfare aziendale nella modalità di “accordo quadro”, infatti solo nei più recenti rinnovi (es. metalmeccanici) si trovano delle regole precise e applicabili senza ulteriori accordi aziendali, ma questo si può attribuire, almeno in parte, alla necessità dei contraenti di compensare i modesti miglioramenti economici con altre utilità per i lavoratori, il welfare aziendale appunto. Dall’esperienza si evince che il welfare aziendale soddisfa pienamente i lavoratori quando è “fatto su misura” per loro, quindi anche nei settori in cui regolamentato dalla contrattazione nazionale, proliferano gli accordi collettivi di secondo livello che – sull’argomento – integrano il contratto collettivo nazionale di lavoro o lo applicano con diverse modalità.
Quanto precede induce a riflettere sul fatto che l’attuale quadro normativo in materia di welfare aziendale rischia di penalizzare le imprese di minori dimensioni, nelle quali non è presente una rappresentanza sindacale di lavoratori e, di conseguenza, non è possibile stipulare contratti collettivi aziendali. Imprese che spesso operano in settori nei quali la contrattazione nazionale e quella interconfederale non regolano il welfare aziendale o lo fanno in modo insufficiente.
Per evitare la limitazione delle spese per il welfare aziendale al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, è opportuno che le imprese di minori dimensioni valutino se e quali accordi territoriali regolino la materia nel settore nel quale operano, tenendo presente che ove non ci siano accordi territoriali nel settore di appartenenza possono fare riferimento anche ad analoghi accordi di altri settori. Si pensi ad una impresa artigiana del settore tessile con sede nella Regione Campania che lavori prevalentemente come “terzista” per un’industria metalmeccanica locale, in assenza di un accordo territoriale del proprio settore in materia di welfare aziendale, potrebbe fare riferimento ad un analogo accordo di una Regione limitrofa ovvero, in assenza anche di questo, ad un contratto collettivo territoriale della filiera metalmeccanica della propria Regione. In realtà anche la ricerca dei contratti collettivi territoriali non è agevole, anche se esiste l’obbligo di depositarli presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (già Direzione territoriale del lavoro), anche ai fini delle agevolazioni tributarie e previdenziali previste dalla legge.
L’accordo collettivo è indubbiamente una forma di garanzia per i lavoratori ma in talune imprese di piccole o piccolissime dimensioni rischia di impedire o rendere più onerose le iniziative di welfare aziendale, è quindi auspicabile – a legislazione invariata – che le parti sociali definiscano contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi interconfederali e contratti collettivi territoriali che consentano anche alle imprese di minori dimensioni, in particolare a quelle ove non siano presenti rappresentanze sindacali dei lavoratori, di erogare senza oneri aggiuntivi fringe benefit ai lavoratori e con forme di flessibilità che facilitino le scelte dei beneficiari.
_____________________________
Ai lettori,
con questo articolo si conclude la mia collaborazione stabile alla Rivista Il Commerci@lista lavoro e previdenza, dopo oltre quattro anni di intenso e gratificante impegno. Ringrazio voi, che mi avete onorato della vostra attenzione, i colleghi Redattori, con i quali ho vissuto un’esperienza esaltante, e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.
I risultati raggiunti sono il frutto di un gioco di squadra nel quale tutti gli “atleti” hanno dato il loro contributo, con fecondi interscambi. Proprio l’articolo che precede e la mia monografia Rappresentatività sindacale al tempo della Gig economy, edita in questo periodo, dimostrano la sintonia che si è creata tra i redattori. Per quanto riguarda l’articolo perché se non avessi conosciuto il collega Loris Beretta di Milano, esperto in welfare aziendale, non avrei mai trattato l’argomento, e per la monografia perché basta leggere il bel contributo di Isabella Marzola di Ferrara su questo stesso numero per notare come l’uno (l’articolo) completi l’altra (la monografia).
* Odcec Roma

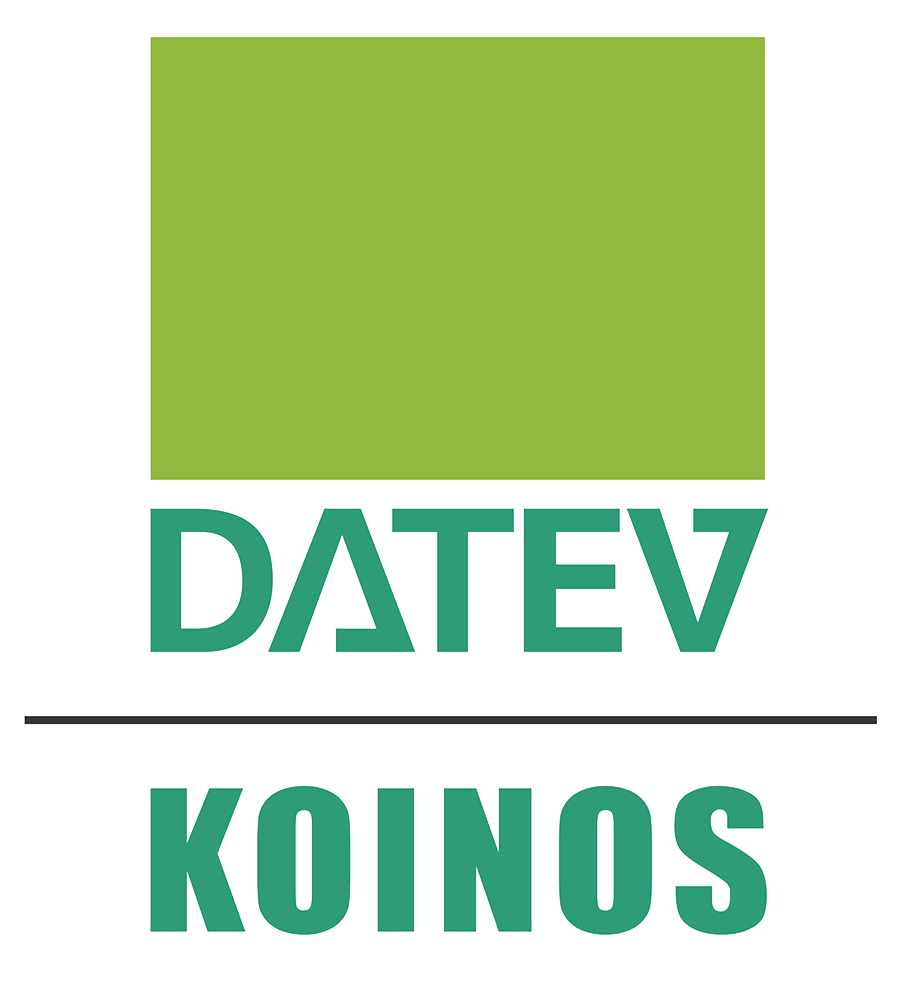






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!