Dopo dieci anni di crisi economica si può fare un bilancio
di Paolo Soro*
Trascorso un decennio dall’inizio della più grande crisi economica mondiale, sembra doveroso fare un “bilancio” degli effetti che ha avuto, in particolare, sul Sistema Italia.
L’8 aprile 2010, il Wall Street Journal usciva con un articolo dall’emblematico titolo: Did “Great Recession” live up to the name? (la “Grande recessione” è stata all’altezza del nome?). L’Autore confrontava la portata della famosa “Grande Depressione” del 1929 con la nuova crisi economica mondiale (originata negli USA, nel 2007, e giunta in Europa l’anno seguente), chiamata “Grande Recessione”. Al di là della denominazione simile, possiamo dire che gli effetti provocati sui mercati internazionali dall’ultima crisi si dimostrano più persistenti e incisivi rispetto alle conseguenze causate dalla crisi del 1929. Se analizziamo la situazione a livello mondiale, è indubbio che, dopo dieci anni, la situazione economica e finanziaria permane negativa; viceversa, la crisi del 1929 ebbe una durata assai inferiore. Il concetto stesso di crisi (volgarizzato in generica situazione di difficoltà finanziarie) mal si addice a indicare l’enorme mutamento economico di cui siamo stati – e tuttora siamo – testimoni. In effetti, sono anni, ormai, che da più parti si sente dire “si intravvedono i primi segnali di ripresa, ma il percorso è ancora lungo”; “dobbiamo tenere duro ancora per qualche anno”; “non possiamo considerarci fuori dalla crisi”; etc. La verità è che l’economia non è una scienza esatta; le variabili soggettive (dunque, imponderabili) sono tante e qualunque previsione è soggetta ad un margine di errore che, mai come in questo periodo, è alto.
Alle intrinseche difficoltà di una scienza non esatta come l’economia si sommano le “asperità” delle sue dottrine, che a volte sono difficili da spiegare e hanno conosciuto nel tempo alterni successi. Si pensi alle teorie macroeconomiche di John Maynard Keynes che sono state soppiantate da quelle di nuovi economisti come il Premio Nobel Friedrich August von Hayek, il propugnatore del laissez faire, ossia di quella che si è rivelata la peggiore e illiberale ricetta utilizzabile in un’economia capitalista mondiale. L’ultimo decennio, durante il quale le teorie keynesiane sono state “congelate”, ha dimostrato che il mercato non è in grado di auto-regolamentarsi e, quindi, il mondo dell’economia si è in gran parte ravveduto, ammettendo che gli insegnamenti di Keynes risultano ancora oggi tra i più affidabili. Tutto questo per dire all’autorevole articolista del Wall Street Journal, che non si può paragonare la più grande crisi economica che il mondo capitalista abbia conosciuto (ossia, quella del 1929), con l’odierna situazione in cui non pare corretto nemmeno parlare di crisi in senso tecnico. In effetti, ci troviamo di fronte a un naturale e incontrollabile riassestamento globale dei mercati, i quali, a seguito di opportune e maggiormente incisive normative, sono alla ricerca del loro reale punto di equilibrio, dopo che le manovre dei grandi poteri internazionali hanno volutamente, per personali tornaconti, falsato la realtà economica mondiale, facendo credere a tutti che detto punto di equilibrio fosse molto al di sopra rispetto a quello effettivo.
In questo contesto, la situazione economica italiana costituisce un “caso particolare”, infatti il nostro Paese da troppo tempo cresce troppo poco e (ahinoi) lentamente. Se è vero che il grado di bontà e di validità dell’economia è direttamente proporzionale alla sua capacità di generare occupazione (indipendentemente dalla tipologia della stessa che, inevitabilmente, cambia negli anni proprio col mutare dell’andamento economico), i dati legati al mercato del lavoro dovrebbero far riflettere non poco. L’Istat, il Ministero del lavoro e l’Inps hanno creato un sistema coordinato per realizzare quelle che hanno chiamato: “informazioni armonizzate, complementari e coerenti”. Orbene, dando alle dichiarazioni politiche il valore meramente propagandistico che hanno, sarà bene perciò limitare la nostra analisi ai numeri puri e semplici. Intanto, incominciamo col dire che occorre “leggere” i dati (specie quelli espressi in valori assoluti), a distanza di tanti anni, con la dovuta oculatezza: la popolazione muta quantitativamente e qualitativamente (calo delle nascite, espatri, immigrati, innalzamento dell’età media, etc.); i paesi sono sempre più internazionali e i mercati a carattere maggiormente globale; la concorrenza aumenta in tutti i settori; il variare delle leggi implica modifiche negli ordinari comportamenti dei lavoratori; fluttuazioni temporali non sono da prendere in considerazione, in quanto dovute a variabili non durature; e via discorrendo.
L’Italia, all’inizio del 2008 (ossia allo scoppio della c. d. crisi), contava 59.619.290 abitanti; dieci anni dopo, gli abitanti sono diventati 60.483.973. Il numero degli occupati al termine del primo anno di crisi era sceso a 25,4 milioni, con una disoccupazione al 6%. Oggi, registriamo 25 milioni di occupati con un tasso ufficiale di disoccupazione pari quasi all’11%, nonostante i vari sgravi, esoneri, incentivi, le orde di giovani che vanno a cercare lavoro all’estero e coloro che, seppure restati in Patria, nemmeno si iscrivono più nelle liste dei lavoratori in cerca di occupazione (e che, dunque, rientrano in una terza categoria difficilmente controllabile: quella degli inoccupati). Inoltre, giusto per dimostrare la correttezza del teorema concernente la diretta corrispondenza tra qualità dell’economia e livello di occupazione, per quanto riguarda la variazione percentuale tra il primo semestre del 2008 e il primo semestre del 2017: il Pil (prodotto interno lordo) italiano registra una diminuzione del 6% e le ore lavorate una diminuzione 5,9%. Più nel dettaglio, alla fine del primo anno di crisi, il Pil era diminuito fino a 850 miliardi; oggi, continuiamo a stare sotto gli 800 miliardi. Le ore lavorate erano scese fino a 11,5 milioni a fine 2008; attualmente siamo ancora sotto gli 11 milioni.
Andando a vedere l’andamento dei grafici di riferimento nel decennio trascorso, si nota un deciso crollo nei primissimi anni di crisi, seguito a una fase altalenante, tendente a un leggero rialzo, pur restando tuttora nettamente al di sotto dei livelli pre-crisi. Tenuto conto dei provvedimenti adottati sia a livello nazionale, sia comunitario e mondiale, ciò significa che i mercati, dopo essersi riassestati ritrovando il loro reale punto di equilibrio (assai inferiore rispetto a quello che risultava ufficialmente), hanno ripreso naturalmente ad ampliarsi, spostando man mano verso l’alto il nuovo punto di equilibrio, gradualmente ma sulla base di una corretta logica macroeconomica keynesiana, con regole nuove e più efficaci. Peraltro, come testé evidenziato, ancora oggi, detto punto di equilibrio resta abbondantemente inferiore rispetto a quello di inizio della crisi, quanto meno per ciò che concerne la situazione degli occupati. Non basta: i dati pubblicati dall’Ocse hanno rivelato che l’Italia è l’unico mercato europeo (insieme alla Grecia) dove la ripresa non ha favorito la crescita di professioni ad alto tasso di qualifiche, magari nell’ambito tecnico-scientifico. In Europa, si è infatti assistito, in media, a un aumento del 7,6% delle professioni ad alta qualificazione, contro il solo +1,93% di quelle a bassa qualificazione. In Italia, l’incremento delle due è stato praticamente identico: +4,78% le professioni ad alto tasso di qualificazione, +4,55% quelle a basso tasso di qualifiche. Fascia alta e fascia bassa aumentano allo stesso modo; anzi, in proporzione, la domanda di lavoro sembra orientata soprattutto verso il basso.
Nel rapporto sul mercato del lavoro, gli economisti fanno notare che la naturale conseguenza del ciclo economico è la seguente: quando comincia una crisi, le imprese prima riducono le ore, ad esempio evitando gli straordinari, ricorrendo agli ammortizzatori sociali e al part-time, ma poi licenziano. Ma, anche questo teorema enunciato dagli economisti fa “acqua”: nell’ultima fase, infatti, quella della (piccola) risalita, l’occupazione in realtà è aumentata più delle ore lavorate.
La causa? L’aumento dei lavori part-time, che, però, a parere dell’Istat, non sarebbero dovuti a una libera scelta dei lavoratori, quanto piuttosto a delle decisioni imposte dalle aziende che, in detto ultimo caso, riguarderebbero sul totale un 19,1% per le donne e un 6,5% per gli uomini. A incidere, inoltre, su detta modifica occupazionale – a parte l’avvento dell’innovazione tecnologica, dei robot, dell’automazione e così via – risultano essere i nuovi rapporti di lavoro brevi, ossia saltuari e/o precari (esempio: i fattorini/rider, i cassieri che lavorano solo la domenica, gli operai assunti per periodi in cui la produzione si intensifica etc.), che coinvolgono più di 4 milioni di persone, usando ogni strumento contrattuale a disposizione, dai contratti a termine alle partite Iva (nel recente passato, come noto, erano i contratti a progetto, i voucher e simili).
Il rapporto Istat, da questo punto di vista, non ci dice nulla che già non si sapesse: gli sgravi contributivi concessi negli anni hanno influenzato i numeri dei rapporti di lavoro permanente. Dopo di che, finiti gli incentivi, i lavori a tempo determinato hanno di nuovo registrato un consistente tasso di crescita, complice anche la paura dei datori di lavoro di dover pagare pure l’iniquo ticket sui licenziamenti per finanziare la Naspi. Tra gli altri dati evidenziati dal rapporto, un ulteriore elemento che per chiunque operi nel mercato del lavoro non rappresenta certo una sorpresa è la ripartizione all’interno della nazione: il nord, con il 66,7% di occupati di oggi contro il 66,5 del 2008, ha recuperato i livelli di 10 anni fa; il sud viceversa è ancora molto indietro rispetto alla situazione precedente alla crisi. Infine, appare doveroso dare un’occhiata ai livelli salariali. Ebbene, depurate dall’inflazione, le retribuzioni pro capite del 2017 sono più basse di 600 euro rispetto a quelle del 2007. Ciò, evidentemente, non può che incidere negativamente sui consumi e sulla redditività generale nel settore del commercio; seppure, non in modo direttamente proporzionale (come giustamente rilevava Keynes), posto che intervengono anche fattori umani legati ai condizionamenti psicologici che guidano le scelte dei consumatori.
Dunque, in quest’ottica, il nostro Paese non solo non ha fatto passi avanti, ma addirittura ha “perso terreno”. Anche gli analisti del Fondo monetario internazionale (Fmi), ora, hanno cambiato idea: per anni hanno propugnato le politiche favorevoli alla riduzione del costo del lavoro per aumentare la competitività; ma non hanno considerato adeguatamente determinate variabili (quali: l’aumento delle disuguaglianze, il fatto che il lavoro non basta più a garantire l’uscita dalla povertà, le tensioni sociali, etc.). Adesso si accorgono della prioritaria necessità di conseguire innanzitutto l’equilibrio complessivo del sistema economico, e, per fare ciò, l’opportunità connessa con l’aumento dei livelli salariali.
L’uomo dovrebbe imparare dai propri errori e una crisi dovrebbe costituire un vero e proprio “master formativo”, ma non è detto che sia così. Per questo è fondamentale che coloro che occupano posti di potere facciano scelte economiche eticamente condivisibili, che favoriscano la crescita nel rispetto delle persone e dei territori, ad esempio non scaricando sulle generazioni future oneri impropri, per ottenere un effimero consenso attuale.
*Odcec Roma

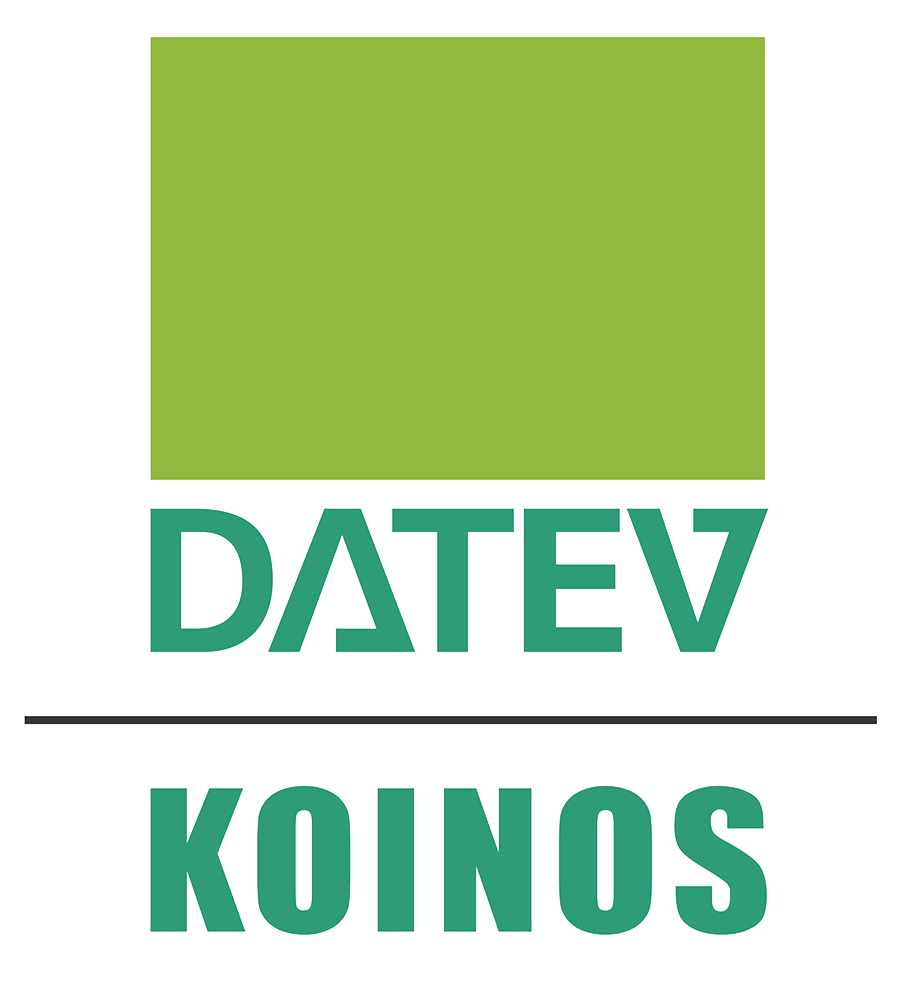






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!