Rassegna di Giurisprudenza
di Bernardina Calafiori* e Francesco Marasco**
Cass. Civ. Sez. Lav., sentenza 12 ottobre 2018, n. 25561: Licenziamento – Intimazione orale – Impugnazione ex art. 6, legge n. 604/1966 – Non sussiste.
Il regime di impugnazione del licenziamento ex art. 6 della legge n. 604/1966, come novellato dall’art.32 della legge n. 183/2010, non trova applicazione con riferimento ai licenziamenti intimati in forma orale, che dunque restano soggetti al solo termine quinquennale di prescrizione.
Il caso deciso con il provvedimento in epigrafe aveva ad oggetto la mancata impugnazione, nei termini di cui all’art. 6 della legge n. 604/1966 (per come modificato dalla legge n. 183/2010), di un licenziamento intimato in forma orale in data 17 dicembre 2009.
I Giudici di primo e secondo grado accoglievano le tesi difensive del lavoratore, dichiarando inefficace il suddetto licenziamento.
Il datore di lavoro ricorreva, pertanto, dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sostenendo che il lavoratore avrebbe dovuto impugnare stragiudizialmente – e non solo giudizialmente – il proprio licenziamento e ciò non era avvenuto. Né tale onere poteva ritenersi soddisfatto con l’invio, da parte del lavoratore, di una lettera “di impugnazione”, pure prodotta in atti, atteso che la stessa sarebbe stata viziata da una “genericità ed indeterminatezza” tali da rendere “impossibile desumere una chiara volontà di impugnare”.
Il Supremo Collegio rigettava il ricorso del datore di lavoro e, ritenuta incontestata l’oralità del licenziamento, enunciava il principio per cui “l’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento orale è sottratta all’onere dell’impugnazione stragiudziale in ragione dell’assenza di un atto scritto”.
Invero, il principio sopra enunciato parrebbe costituire “diritto vivente” secondo l’oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le prime, Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza del 18 ottobre 1982, n. 5394).
A tale orientamento farebbe, tuttavia, eccezione una certa giurisprudenza di merito, secondo la quale il licenziamento intimato in forma orale è, in realtà, non già inefficace, bensì “nullo” e, come tale, “invalido” (cfr. Trib. Roma, Sez. Lav., sentenza del 24 novembre 2014, est. Armone). Ricostruita la natura del licenziamento orale in termini di “invalidità”, lo stesso andrebbe ricondotto, secondo la citata giurisprudenza, nell’alveo di applicazione dell’art. 32 della legge n. 183/2010, atteso che, ai sensi del comma 2, “le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 … si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”.
Si tratta di un orientamento interessante e, tuttavia, rimasto ad oggi isolato.
* * *
Cass. Civ. Sez. Lav., sentenza 3 ottobre 2018, n. 24118: Contratto di lavoro – rapporto di lavoro – Adibizione a mansioni inferiori – Rifiuto del lavoratore di svolgerle– Illegittimità.
Nel caso in cui vengano attribuite mansioni inferiori al livello di inquadramento contrattuale, il lavoratore non può aprioristicamente rifiutarsi di svolgerle, ma deve richiedere, in via giudiziale, la riconduzione della di lui prestazione lavorativa nell’ambito della qualifica di appartenenza, con contestuale assegnazione di mansioni corrispondenti al proprio livello di inquadramento.
Il rifiuto aprioristico del lavoratore di svolgere la propria prestazione è ammissibile soltanto in caso di totale inadempimento delle prestazioni gravanti sulla parte datoriale, ovvero in caso di un inadempimento del datore di lavoro che sia talmente grave da incidere in maniera irrimediabile sule esigenze vitali del lavoratore (ad es.: mancato approntamento delle misure di sicurezza), ovvero ancora in caso di attribuzione di mansioni che possano esporre il lavoratore a responsabilità penali.
Il caso deciso con il provvedimento in epigrafe aveva ad oggetto l’impugnazione, da parte di una lavoratrice, del licenziamento a lei comminato per giustificato motivo soggettivo, in quanto ella – inquadrata come cuoca di IV livello (CCNL Turismo Pubblici Esercizi) ed adibita presso un servizio di ristorazione appaltato ad una scuola d’infanzia comunale – si era rifiutata di servire in classe le colazioni da lei stessa preparate.
Il Giudice di prime cure accoglieva le domande con cui la lavoratrice tendeva ad ottenere l’annullamento del licenziamento così intimato. La statuizione di primo grado veniva, poi, confermata in appello.
In particolare, i Giudici di seconde cure ritenevano che l’attività richiesta dalla società datrice di lavoro esulasse dai compiti propri della qualifica di appartenenza della lavoratrice, di modo che a quest’ultima non poteva essere addebitato alcun “notevole inadempimento” (come invece prospettato nella lettera di licenziamento).
Tale statuizione veniva impugnata dalla società datrice di lavoro, che eccepiva l’erroneità della sentenza di appello anche per non aver fatto applicazione di quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il lavoratore non può rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta senza prima agire giudizialmente per ottenere che le mansioni pretese siano ricondotte nell’ambito qualifica di appartenenza”.
La Suprema Corte di Cassazione, pur rilevando che la figura dell’“addetto mensa” – ossia, di colui che serve i pasti – è inquadrata in un livello (i.e.: il VI livello) diverso da quello in cui è inquadrata la figura di “cuoco” (i.e.: il IV livello), la lavoratrice non avrebbe potuto rifiutare di svolgere la prestazione richiesta.
Costituisce orientamento giurisprudenziale oramai costante quello per cui lo svolgimento di mansioni inferiori in tanto può essere rifiutato dal lavoratore, in quanto la reazione di quest’ultimo sia improntata a “caratteri di positività” e risulti “proporzionata e conforme a buona fede” (cfr., tra le prime, Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza dell’8 agosto 2003, n. 12001).
In tale ottica, il rifiuto tout court del lavoratore di svolgere le nuove, inferiori,mansioni è ex se ingiustificato, a meno che a tali mansioni non segua un inadempimento totale del datore di lavoro verso gli obblighi su di lui gravanti, ovvero a meno che tali mansioni non ledano irreparabilmente le esigenze vitali del lavoratore (si pensi all’ipotesi di mansioni che devono essere svolte in assenza della benché minima misura di sicurezza), ovvero ancora espongano il lavoratore a responsabilità di natura penale.
Così ricostruito il quadro giurisprudenziale, il Supremo Collegio cassava la sentenza impugnata, sancendo che la sentenza impugnata avrebbe dovuto verificare se il rifiuto della lavoratrice fosse “proporzionato” rispetto al presunto inadempimento della controparte datoriale.
Del resto, il criterio a “proporzionalità” tra i corrispettivi inadempimenti non costituisce affatto un criterio nuovo, avendo esso già trovato applicazione in altri casi, tra cui si ricordano quelli aventi ad oggetto il mancato pagamento di “quattro mensilità di retribuzione” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza del 2 aprile 2004, n. 6564), il rifiuto del lavoratore di prendere servizio presso la nuova sede cui è stato trasferito (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza del 1° luglio 2010, n. 15658) ed il rifiuto del lavoratore di adottare una misura di sicurezza ritenuta “eccessivamente macchinosa” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza del 7 maggio 2013, n. 10553).
* * *
Trib. Bologna, Sez. Iv, sentenza 1° marzo 2018: rapporto di lavoro – retribuzione – Insinuazione al passivo – Membro del Consiglio di Amministrazione – Ammissibile.
La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non è incompatibile con la qualità di membro del Consiglio di Amministrazione. L’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato è, invece, incompatibile con la qualità di amministratore unico.
Il caso deciso con il provvedimento in epigrafe traeva origine dall’esclusione, dallo stato passivo, di un importo rivendicato da un creditore a titolo di retribuzioni presuntamente maturate nei confronti della società decotta, ma da quest’ultima non corrisposte. Avverso tale esclusione, il creditore proponeva opposizione ai sensi dell’art. 98 della “Legge Fallimentare”. Si costituiva il Fallimento, rilevando che il creditore de quo non aveva mai svolto attività di lavoro in regime di subordinazione, ma soltanto compiti strettamente inerenti al rapporto organico connesso alla di lui qualità di “membro del Consiglio di Amministrazione”.
Tant’è che, rilevava il fallimento, il suddetto creditore aveva incamerato, nel corso del tempo, un corrispettivo di gran lunga superiore a quello che sarebbe a lui spettato a titolo di retribuzione sulla base del contratto collettivo applicabile.
Il Giudice bolognese riteneva, tuttavia, di accogliere l’opposizione.
E ciò non solo perché la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato era comprovata da plurimi documenti (tra cui: lettera di assunzione, buste paga e CUD), ma anche perché nulla osta a che un membro del Consiglio di Amministrazione sia anche lavoratore subordinato.
All’interno di un collegio, infatti, la volontà gestionale, anche con riferimento alla costituzione di rapporti di lavoro, è riconducibile ad un organo diverso dai singoli membri che lo compongono. Ciò che, invece, non si verifica in presenza di un amministratore unico, ove la volontà di costituire un “rapporto di lavoro” con quest’ultimo non può essere ricollegata “a una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore” (cfr. Trib. Como, Sez. II, ord. 16 febbraio 2016; cfr., inoltre, Cass. Civ., sentenza del 22 dicembre 1983, n. 7562; Cass. Civ., sentenza del 14 maggio 1991, n. 5358; Cass. Civ.,sentenza del 7 marzo 1996 n. 1793; Cass. Civ., sentenza del 22 marzo 2013, n. 7312). Allo stesso tempo, però, la giurisprudenza dianzi citata non ha mancato di ricordare che, pur essendo la qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione compatibile con un rapporto di lavoro subordinato, per la sussistenza di quest’ultimo occorrerà pur sempre accertare l’assoggettamento del predetto membro “al potere direttivo di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso” (cfr., in termini, Cass. Civ, sentenza del 28 giugno 2004, n. 11978; Cass. Civ, sentenza del 13 giugno 1996 n. 5418; Cass. Civ, sentenza del 6 marzo 1987 n. 2386; Cass. Civ, sentenza del 5 dicembre 1986, n. 7228; Cass. Civ, sentenza del 11 ottobre 1984 n. 5097).
* Avvocato, socio fondatore dello Studio Legale Daverio & Florio
** Avvocato dello Studio Legale Daverio & Florio

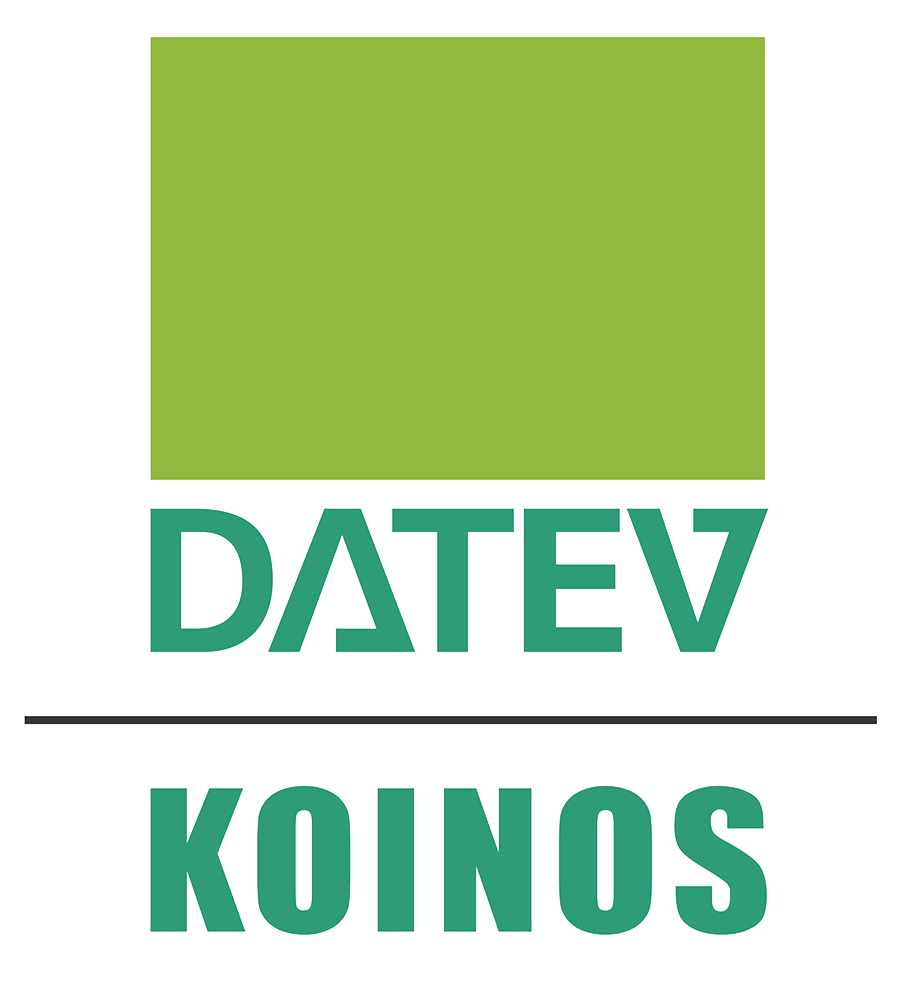






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!