Rassegna di giurisprudenza
a cura dell’avv. Bernardina Calafiori – socio fondatore Studio Legale Daverio & Florio*
Cass. Civ. Sez. lav., 4 luglio 2016, n. 13578 Somme riconosciute al lavoratore quale risarcimento del danno da demansionamento – Contribuzione previdenziale – Non dovuta – Inconfigurabilità di un lucro cessante.
Le somme erogate dalla parte datoriale a titolo di risarcimento del danno da demansionamento vanno qualificate quale danno emergente, derivato dal mancato incremento del bagaglio professionale posseduto, e quindi non correlate alla retribuzione, notoriamente utile solo come parametro della valutazione equitativa ex art. 1126 c.c.. Per tali somme non sono dovuti i contributi.
Una nota casa editrice veniva condannata al risarcimento del danno da demansionamento nei confronti di una propria dipendente. Su tale somma il datore di lavoro non versava i contributi previdenziali.
L’INPGI chiedeva ed otteneva dal Tribunale competente decreto ingiuntivo per il versamento dei contributi previdenziali sulla somma riconosciuta in sentenza alla lavoratrice, quale risarcimento del danno da demansionamento.
Avverso il suddetto decreto il datore di lavoro proponeva opposizione, affermando l’inassoggettabilità a contribuzione previdenziale della somma in parola.
I giudici di merito revocavano il decreto ingiuntivo opposto, escludendo che nella specie la somma riconosciuta a titolo risarcitorio fosse soggetta a contribuzione previdenziale.
In particolare, secondo i giudici di merito, il danno riconosciuto in sentenza alla lavoratrice aveva reintegrato l’impoverimento delle capacità professionali acquisite dalla giornalista (cd. danno emergente) e non già la perdita di futuri guadagni (cd. lucro cessante), “la cui risarcibilità richiede almeno un riferimento a specifiche occasioni perse, riferimento cui però non vi era traccia nella sentenza” (conclusiva del giudizio avente ad oggetto il lamentato demansionamento).
Avverso tale decisione l’INPGI proponeva ricorso in Cassazione affermando che in base alla più recente normativa il reddito da lavoro dipendente a fini previdenziali è costituito da tutte le somme ed i valori a qualunque titolo maturati nel periodi di riferimento in relazione al rapporto di lavoro. La somma erogata alla giornalista a titolo di risarcimento del danno alla professionalità costituiva un’utilità economica, non esclusa per legge dalla sottoponibilità a contribuzione, trattandosi di somma liquidata a titolo di risarcimento dei minori futuri guadagni (lucro cessante). Il solo risarcimento escluso dall’obbligo contributivo era, secondo consolidata giurisprudenza, quello relativo al danno emergente (per perdita di retribuzioni), mentre per danno emergente doveva intendersi il risarcimento di ogni perdita di utilità attuale, già presente nel patrimonio del danneggiato. Il lucro cessante, invece, sarebbe derivato dal venir meno di un reddito goduto in precedenza, nonché di ogni mancato guadagno eventuale, che si sarebbe prodotto in futuro, in eccedenza rispetto a quello ristorato come perdita attuale o danno emergente.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando l’orientamento espresso dai giudici di merito.
La Corte ha anzitutto ritenuto congrua la motivazione in base alla quale nella specie il risarcimento del danno avesse reintegrato l’impoverimento delle capacità professionali acquisite dalla giornalista, qualificato come danno emergente, e non già la perdita di futuri guadagni, “lucro cessante, che richiede per il relativo risarcimento un riferimento a specifiche occasioni perse”.
La Corte inoltre ha ritenuto dirimente l’applicabilità nella specie dell’art. 12, comma 4, lett. c) della L. n. 153 del 1969, in base al quale sono escluse dall’imponibile previdenziale “c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni”.
In linea generale, quindi, l’assoggettabilità a contribuzione previdenziale delle somme riconosciute a titolo di danno da demansionamento, dipende dalla configurabilità o meno – a seconda delle circostanze del singolo caso concreto – di un lucro cessante, riconoscibile quando il pregiudizio professionale del lavoratore abbia comportato la perdita di specifiche e concrete (e ben individuate) occasioni di crescita e sviluppo professionale e quindi la perdita di specifiche occasioni di guadagno. Ove invece non sussista uno specifico riferimento ad occasioni di guadagno perdute (v. sul punto anche Cass. n. 16014/2004) e venga riconosciuto un più generico pregiudizio alla professionalità, le somme riconosciute a ristoro di quest’ultimo non sono assoggettabili a contribuzione previdenziale.
Tribunale di Venezia. Sez. lav., 5 luglio 2016, n. 336
Avanzamento di carriera – Esclusione del periodo di congedo di maternità ai fini del passaggio al livello superiore – Condotta discriminatoria – Sussistenza.
Deve affermarsi la natura discriminatoria della mancata progressione di carriera della lavoratrice, contrattualmente prevista, conseguita nell’interpretazione del contratto collettivo nazionale di lavoro che si risolve nell’omessa valutazione dei periodi di assenza dal lavoro per congedo parentale e per congedo di maternità, dovendosi invece applicare una nozione unitaria di anzianità di servizio ai sensi degli artt. 22 e 34 del D.Lgs. 151/2001 e rivelandosi discriminatoria la condotta del datore in quanto finisce per limitare e rallentare la carriera di una donna rispetto ad un uomo e rispetto alle altre donne che non hanno figli, in ragione della propria maternità, senza che vi sia una giustificazione e senza che tale rallentamento di carriera sia necessario e proporzionato.
Nel caso deciso con la sentenza indicata in epigrafe, il CCNL applicato prevedeva un avanzamento di carriera – pur nell’espletamento delle medesime mansioni e del medesimo ruolo – e l’inquadramento in un livello retributivo superiore, ancorato esclusivamente all’anzianità di servizio.
La ricorrente aveva fruito, in occasione della nascita di due figli, rispettivamente di due periodi di congedo di maternità e di periodi successivi di congedi parentali.
I suddetti periodi non venivano computati dal datore di lavoro ai fini dell’avanzamento di carriera come previsto dal CCNL applicato. La lavoratrice agiva in giudizio chiedendo che venisse dichiarata la natura discriminatoria della condotta datoriale, con condanna al riconoscimento del livello superiore rivendicato e delle relative differenze retributive.
Il Tribunale ha ritenuto discriminatoria la condotta del datore di lavoro ed ha accolto tutte le domande della lavoratrice.
Il Tribunale ha ritenuto anzitutto che nella specie la previsione contrattuale invocata dalla lavoratrice non richiedeva espressamente un periodo di servizio effettivo ai fini dell’avanzamento di carriera. In ogni caso, ha avuto cura di precisare il Giudice nella motivazione, anche a volere ritenere che il Contratto Collettivo richiedesse un periodo di servizio effettivo, si tratterebbe comunque di un’ipotesi di discriminazione indiretta, comunque censurabile.
In particolare, il Giudice ha ritenuto che nella specie non potesse ritenersi operante il principio in base al quale il “rallentamento” della carriera della lavoratrice madre può ritenersi legittimo alla luce di peculiari ed obiettive esigenze e secondo criteri di ragionevolezza. In altre parole il Giudice ha inferito la natura discriminatoria della condotta denunciata anche dal fatto che si trattava di una progressione nel livello retributivo di inquadramento per lo svolgimento del medesimo ruolo e delle medesime mansioni (e quindi senza alcuna necessità obiettiva di un’anzianità ancorata al servizio effettivo per l’acquisizione di un diverso grado di autonomia, di maggiori competenze ed esperienza, etc.. ).
Nella motivazione, inoltre, il Giudice ha dato piena applicazione all’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2001, in base al quale i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, e gli stessi periodi sono considerati come attività lavorativa ai fini della progressione di carriera. Come noto, analoga previsione è contenuta nell’art. 34 del D.Lgs citato con riferimento ai periodi di congedo parentale.
Cass. Civ. Sez. lav., 18 luglio 2016, n. 14621 Tossicodipendenza – Programma di recupero presso struttura abilitata – Diritto alla conservazione del posto – Abbandono del programma di recupero– Licenziamento per giustificato motivo soggettivo – Legittimità
Il diritto alla conservazione del posto di lavoro compete al lavoratore tossicodipendente allorquando (e per il tempo in cui) egli sia materialmente impedito a rendere la prestazione lavorativa per eseguire il trattamento di disintossicazione; ne consegue che ove il programma terapeutico e riabilitativo sia attuato presso una struttura del servizio pubblico o presso una equivalente idonea struttura riabilitativa, l’abbandono di questa struttura, e il definitivo volontario allontanamento da essa da parte del tossicodipendente fa venir meno il presupposto di fatto costitutivo del diritto alla conservazione del posto ed esclude quindi il diritto del predetto alla conservazione stessa: e ciò, appunto, a causa del venir meno dell’impedimento a prestare l’attività lavorativa che legittimava la sospensione dell’obbligo del lavoratore tossicodipendente di eseguire la prestazione oggetto del rapporto di lavoro. E, con il venir meno del diritto alla conservazione del posto, correlativamente e automaticamente, si ripristina l’obbligo del lavoratore di riprendere servizio e di eseguire la prestazione cui è contrattualmente tenuto.
Una lavoratrice tossicodipendente accedeva ad un programma di recupero presso una struttura abilitata, e rimaneva assente dal lavoro con diritto alla conservazione del posto secondo la normativa vigente.
Successivamente abbandonava la struttura precedentemente segnalata al datore di lavoro ed interrompeva il programma di recupero, per proseguire il trattamento presso un’altra comunità.
Il datore di lavoro, essendo venuto a conoscenza dell’abbandono della struttura e non avendo ricevuto altra comunicazione dal lavoratore, gli contestava l’assenza ingiustificata dal servizio (senza alcuna revoca espressa del periodo di aspettativa precedentemente concesso e senza alcuna previa intimazione a riprendere servizio). In esito al procedimento disciplinare veniva intimato il licenziamento per giusta causa.
I giudici di merito respingevano l’impugnazione della lavoratrice e confermavano la legittimità del licenziamento, seppure “derubricandolo” a licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
La lavoratrice proponeva ricorso in Cassazione, adducendo:
- che non le si poteva imputare un’assenza
dal servizio in quanto il suo status giuridico era quello di dipendente in aspettativa, per cui il rapporto di lavoro era a tutti gli effetti sospeso, mancando un preciso obbligo di presenza in servizio;
- che essa ricorrente non era in quel periodo
in grado di rendersi conto delle proprie azioni in conseguenza dello stato di tossicodipendente sottoposta a programma riabilitativo, per cui sarebbe stato agevole dedurne che non vi era stata una volontà piena di porre in essere un’assenza arbitraria. Né, tantomeno, il cambiamento di struttura per la prosecuzione di un diverso trattamento di recupero riabilitativo poteva equipararsi alla volontà di interrompere il programma curativo di disintossicazione; né poteva ignorarsi che le spettava il diritto alla conservazione del posto di lavoro durante il periodo in cui era stata materialmente impedita a rendere la prestazione per seguire il predetto trattamento terapeutico.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito e confermando la legittimità del licenziamento.
In particolare è stata ritenuta irrilevante la prosecuzione del programma presso altra struttura, una volta interrotto il programma di recupero in corso.
Il lavoratore materialmente impedito a rendere la prestazione lavorativa per eseguire il trattamento di disoccupazione ha diritto alla conservazione del posto. L’abbandono della struttura e del programma di recupero determina il venir meno del fatto costituivo del predetto diritto, con correlativo e automatico ripristino dell’obbligo di rendere la prestazione. Da qui la legittimità della contestazione dell’assenza arbitraria e del conseguente provvedimento espulsivo.
Quanto poi alle censure relative alla mancata considerazione dell’elemento soggettivo della condotta e allo stato di incapacità che avrebbe impedito alla lavoratrice di comprendere appieno di porre in essere un’assenza arbitraria, la Corte di Cassazione ha ritenuto congruamente motivata la decisione dei giudici di appello nella parte in cui hanno dato rilevanza a tale profilo al solo fine di convertire il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, per il resto confermando la legittimità del provvedimento intimato.
*Studio Legale Daverio & Florio Milano

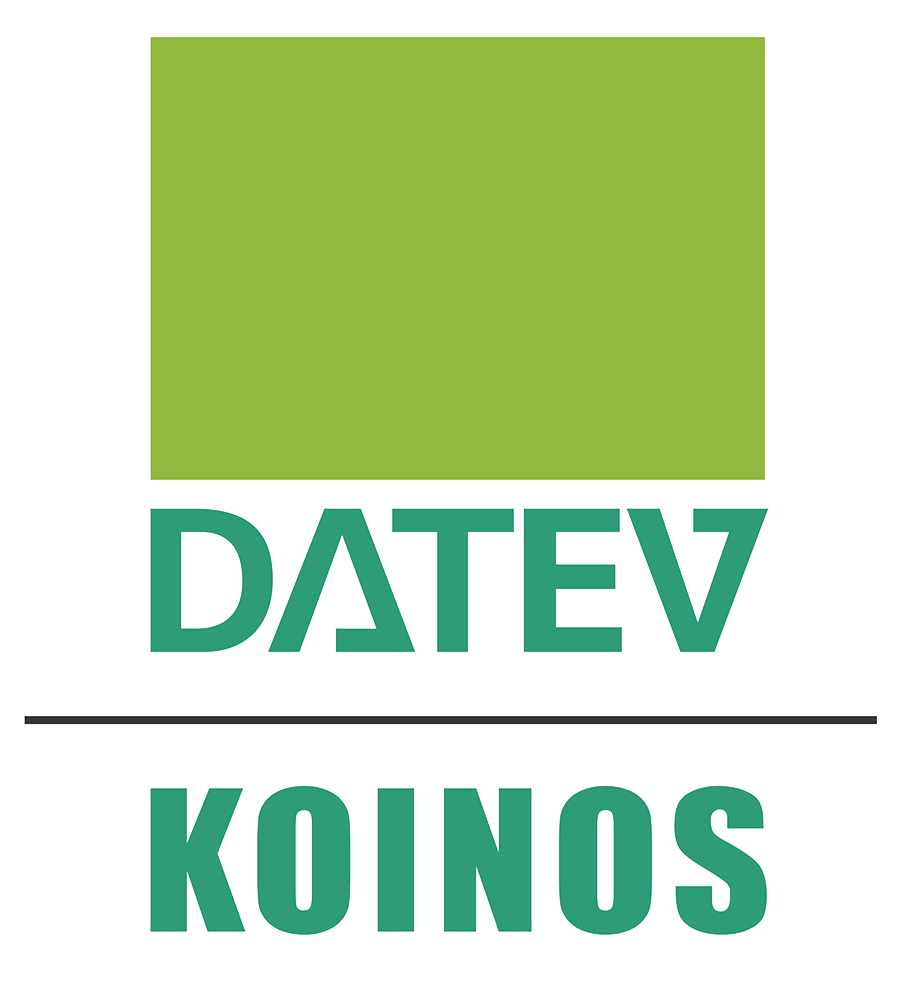






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!