“Danno comunitario”: le accese dispute e le possibili soluzioni
di Gaetano Giannì*
Il lavoropubblico“privatizzato”continua a generare aspri dibattiti interpretativi e divergenze applicative notevoli. Ciò non vuol dire che il progetto normativo di rendere in qualche modo omogenea la disciplina dei rapporti di lavoro tra il settore privato e quello pubblico possa dirsi per questo fallito. Anzi la “privatizzazione” del lavoro pubblico ha certamente contribuito a ridurre disuguaglianze ingiustificate ed a conferire certezza al diritto nell’ambito del pubblico impiego. Tuttavia permangono aree di forte contrasto, mosse da oggettive difficoltà interpretative, aggravate dalla riluttanza degli operatori a superare assetti giuridico istituzionali consolidati. Così capita di dovere assistere a situazioni che, pur nel disastrato sistema giudiziario italiano, non sono per fortuna per nulla frequenti. Ci si riferisce in particolare ad una vicenda verificatasi recentemente: un giudice di merito (Tribunale di Velletri, sentenza del 14 marzo 2017) ha sconfessato e criticato apertamente una decisione della Corte di Cassazione, che era stata presa appena un anno prima a Sezioni Unite, ossia in quella forma che dovrebbe rappresentare la massima espressione della funzione nomofilattica. Dunque nemmeno l’autorevolezza di precedente proveniente dal supremo gradino della giurisprudenza di legittimità, dalle Sezioni Unite per l’appunto, sembra più riuscire ad essere decisiva per un giudice di tribunale, che nel caso in esame se ne è distaccato con decisa convinzione. Ad attenuare la stranezza dell’evento soccorre la considerazione del tema intorno a cui si controverte, una questione complessa e spinosa, foriera di rilevanti implicazioni e difficile da risolvere per i troppi nodi che l’avviluppano.
Contesto in cui è maturata la sentenza n. 5072 del 2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Il Supremo Collegio è stato chiamato al difficile compito di dirimere una volta per tutte le dispute intorno alla interpretazione dell’art. 36, co. 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Come è noto, il d.lgs. 165/2001 costituisce una delle pietre miliari del processo di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego. Per la parte che qui interessa, dopo avere confermato la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato o in altre forme flessibili, al quinto comma dell’art. 36 – in coerenza con i principi giuridici costituzionali in materia – ha stabilito perentoriamente che stipulazione di contratti di lavoro flessibili, fatta in violazione di norme di legge, non può giammai comportare «la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione». Inoltre «il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative».
Come era lecito attendersi, man mano che si veniva formando una giurisprudenza particolarmente rigorosa in materia di contratto di lavoro a tempo determinato nel settore privato, in particolare sulla interpretazione degli stretti vincoli di legittimità del d.lgs. 368/2001, parte della dottrina e della giurisprudenza non hanno risparmiato critiche aspre alla differente consistenza delle tutele nei due settori del diritto del lavoro, caratterizzato quello privato dalla “sanzione” forte della reintegrazione, non ipotizzabile invece in quello pubblico. Tanto più che si è subito compreso come l’insieme dei principi garantisti cui è soggetta la disciplina del risarcimento del danno nel nostro ordinamento (allegazione del danno, onere della prova, quantificazione, etc.) abbia finito per rendere estremamente difficile l’applicazione di conseguenze risarcitorie, a fronte di stipulazioni illegittime di contratti di lavoro flessibili. Una tale realtà portava con sé una doppia frustrazione. Da un lato infatti i lavoratori si ritrovavano nella sostanza privi di tutela. Dall’altro lato, la mancanza di un adeguato apparato sanzionatorio confliggeva con la necessità, soprattutto nell’ambito dei contratti a termine, di ottemperare ai principi giuridici di livello europeo, che hanno sempre imposto agli stati membri di approntare misure sanzionatorie adeguate, idonee a scoraggiare la reiterazione di condotte illegittime.
Una tale analisi, in realtà, sembrava essere condivisa un po’ da tutti gli interpreti e gli operatori che si sono occupati della materia. A dividerli era la prospettazione dei rimedi da adottare. Da una parte c’era chi frenava sulla possibilità che si potessero forzare i principi positivi consolidati espressi dal nostro ordinamento in tema di risarcimento del danno, fino ad applicare indennizzi predeterminati e sganciati dalla sussistenza di un danno. Dall’altro c’era invece chi riteneva che per superare le distorsioni di una disciplina giuridica insoddisfacente per i lavoratori ed illecita per l’ordinamento europeo, si potesse trarre da quest’ultimo la fonte per affermare principi giuridici inediti in materia risarcitoria, perseguendo anche la finalità di appagare l’esigenza di giustizia sostanziale a fronte di comportamenti illegittimi della pubblica amministrazione (PA). In qualche modo, le SS.UU. della Corte di Cassazione si sono allineate a questa ultima linea interpretativa.
Non possiamo esimerci dall’avvertire che il tema trattato è foriero di innumerevoli e gravi problematiche. Dai contrasti tra le fonti di diritto multilevel, alla esatta interpretazione delle norme e delle finalità contenute nella direttiva 1999/70/CE, dai confini delle interpretazioni “orientate” (costituzionalmente, al diritto dell’UE) alla tipologia di conseguenza sanzionatoria da ritenersi più idonea ad essere applicata “analogicamente” al caso di specie, se quella del licenziamento e dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori (legge 300/1970) o quella prevista dall’art. 32 della legge 183/2010 (tema quest’ultimo su cui la sentenza delle SS.UU. in parola si è lungamente soffermata). La questione di specifico interesse per questo contributo è tuttavia solo quella della natura della conseguenza risarcitoria che la Cassazione ha disegnato con il deposito della sentenza n. 5072 del 2016. Soprattutto la giurisprudenza, successiva alla detta sentenza, ha interpretato il rimedio ipotizzato dalla Suprema Corte come una ipotesi di «sanzione ex legge» (così per esempio la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 3672/2016, del 22 giugno 2016) oppure come una presunzione iuris et de iure, fatto che ha innescato la dura presa di posizione del Tribunale di Velletri (oltre che di parte della dottrina).
Ciò che ha affermato la Cassazione con la sentenza 5072/2016
La causa aveva ad oggetto l’accertamento della legittimità di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da un soggetto pubblico, ma alle SS.UU. è stata demandata la decisione sulle conseguenze da applicare una volta accertata l’illegittimità dei contratti. Il dato normativo da interpretare e applicare è quello contenuto nell’art. 36, co. 5, d.lgs. 165/2001, ove si afferma: «In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative».
La materia è molto complessa e non è possibile dare conto della disputa in atto senza presentare, con un minimo di dettaglio, la sentenza delle SS.UU. in questione.
La normativa europea che influenza la disciplina del contratto a termine è, come è noto, contenuta nella Direttiva 1999/70/CE, attuativa dell’accordo quadro sottoscritto dalle Organizzazioni intercategoriali UNICE, CEEP e CES. Secondo la Suprema Corte ciò che «maggiormente interessa al fine di decidere la presente controversia è la clausola 5, che prevede misure di prevenzione degli abusi». Più avanti nella sentenza il concetto viene ripetuto e specificato: «Ciò che però maggiormente rileva in causa è l’attuazione della clausola 5 dell’accordo quadro, alla quale possono riferirsi gli artt. 4 e 5, rispettivamente sulla disciplina della proroga e sulla successione di contratti a termine; disposizioni dirette appunto a contrastare l’abusivo ricorso al contratto a termine come richiesto dalla clausola 5 dell’accordo quadro». Sono pertanto le violazioni di tali due articoli del d.lgs. 368/2001 a richiedere sanzioni adeguate, soprattutto nei rapporti di pubblico impiego, nei quali – come si è detto, ed è noto – non è prevista, né possibile, la reintegrazione in servizio quale effetto della violazione delle norme che disciplinano proroghe e rinnovi contrattuali.
Ed è proprio l’art. 36, co. 5, d.lgs. 165/2001, in coerenza con il nostro ordinamento costituzionale, a vietare la reintegrazione in servizio come sanzione del contratto illegittimo nel pubblico impiego. Le SS.UU. si chiedono quindi, in tale contesto «… cosa intende per danno risarcibile il d.lgs. 165 del 2001 cit. ex art. 36, comma 5 … La norma non aggiunge altro e quindi deve farsi riferimento alla regola generale della responsabilità contrattuale posta dall’art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita, nella specie dal lavoratore, come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta». Di certo, si precisa «il danno non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato, perché una tale prospettiva non c’è mai stata … Lo stesso art. 36, comma 5, cit., definisce il danno risarcibile come derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e non già come derivante dalla perdita di un posto di lavoro». Quindi «Il danno è un altro… Il lavoratore, che abbia reso una prestazione lavorativa a termine subisce gli effetti pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi. … Si può soprattutto ipotizzare una perdita di chance, nel senso che, se la pubblica amministrazione avesse operato legittimamente emanando un bando di concorso per il posto, il lavoratore, che si duole dell’illegittimo ricorso al contratto a termine, avrebbe potuto parteciparvi e risultarne vincitore. Le energie lavorative del dipendente sarebbero state liberate verso altri impieghi possibili ed in ipotesi verso un impiego alternativo a tempo indeterminato. Il lavoratore che subisce l’illegittima apposizione del termine o, più in particolare, l’abuso della successione di contratti a termine rimane confinato in una situazione di precarizzazione e perde la chance di conseguire, con percorso alternativo, l’assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato». Ma, avverte la Corte a questo punto «l’onere probatorio di tale danno grava interamente sul lavoratore … Pur potendo operare il regime delle presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), però indubbiamente il danno una volta escluso che possa consistere nella perdita del posto di lavoro occupato a termine può essere in concreto di difficile prova… di qui il monito della Corte di giustizia con riferimento all’ipotesi dell’abuso del ricorso al contratto a termine».
Le SS.UU. si dilungano anche su tutte le «misure energetiche» che hanno rafforzato la dissuasività del ricorso a contratti a termine illegittimi (responsabilità del dirigente, etc.). Tuttavia tali misure non sono sufficienti ad assicurare una forte dissuasività riguardo agli abusi, ritiene la Corte, almeno finché «il diritto a detto risarcimento è subordinato all’obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione. … È questo uno snodo decisivo della questione portata all’esame di queste sezioni unite». Deve quindi superarsi tale «snodo decisivo». La Corte intravede due vie d’uscita: da un lato, può essere sollevato incidente di costituzionalità, per violazione dell’art. 117 Costituzione, co. 1. Tuttavia «prima di sollevare l’incidente di costituzionalità e come condizione preliminare di ammissibilità c’è da sperimentare la possibilità di un’interpretazione adeguatrice». Ma, avverte «L’interpretazione adeguatrice, orientata alla conformità costituzionaledella normativa ordinaria, si muove comunque nel perimetro delle interpretazioni plausibili e non svincola del tutto il giudice dal dato positivo della norma interpretata. Sussiste si è osservato un limite all’interpretazione adeguatrice al di là della quale c’è solo l’incidente di costituzionalità (cfr., in altra materia, Corte cost. n. 77 del 2007)». Tale fondamentale osservazione della Corte, decisa, concisa ed incisiva, non dovrebbe mai essere scordata o sottovalutata, perché riguarda le fondamenta del nostro ordinamento istituzionale e costituzionale: il dato positivo della norma, l’interpretazione plausibile costituiscono limiti invalicabili della cd. interpretazione adeguatrice.
A questo punto si può chiudere il cerchio sulla soluzione data dalla Suprema Corte alla questione sottoposta al suo vaglio. Per superare l’obiezione della CGE sulla effettiva dissuasività, effettività, proporzionalità della sanzione prevista dall’art. 36, co. 5, d.lgs. 165/2001 la Corte afferma che nel caso di specie «il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo … La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria, sì che il danno così determinato può qualificarsi come ‘danno comunitario’». Ma precisa: «L’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, cit. ha una diversa valenza secondo che sia collegata, o no, alla conversione del rapporto. Per il lavoratore privato l’indennizzo ex art. 32, comma 5, è in chiave di contenimento del danno risarcibile per essere o poter essere l’indennizzo meno del danno che potrebbe conseguire il lavoratore secondo i criteri ordinari; Per il lavoratore pubblico invece l’indennizzo ex art. 32, comma 5, è, all’opposto, in chiave agevolativa, di maggior tutela nel senso che, in quella misura, risulta assolto l’onere della prova del danno che grava sul lavoratore». Tali concetti vengono ribaditi più avanti: «L’indennità ex art. 32, comma 5, quindi, per il dipendente pubblico che subisca l’abuso del ricorso al contratto a tempo determinato ad opera di una pubblica amministrazione, va ad innestarsi, nella disciplina del rapporto, in chiave agevolativa dell’onere probatorio del danno subito». Al lavoratore pubblico, a differenza di quello privato, per il quale l’indennità è prevista in misura fissa, avendo pure la sanzione del licenziamento «non è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso … si traducano in un danno patrimoniale più elevato».
La “ribellione” del Tribunale di Velletri
Come si è anticipato, con una operazione abbastanza inconsueta, il Tribunale di Velletri, facendosi interprete delle critiche mosse da parte della dottrina alla decisione della Suprema Corte, nel decidere una causa sottoposta alla sua giurisdizione, si è nettamente discostato dai principi appena espressi dalle SS.UU.. Senza entrare troppo nel merito della decisione (sent. 14 marzo 2017, est. Russo; la si può trovare in ADL, 4-5 2017, p. 1209, nota Riccobono), basti sottolineare come il giudice di merito abbia nella sostanza ritenuto che il nostro ordinamento interno non consentirebbe una interpretazione “adeguatrice” come quella propugnata dalla Corte di Cassazione. Le motivazioni della sentenza sono lunghe e complesse, e si soffermano su ogni aspetto delle questioni affrontate, formando una specie di specchio che, seguendo lo stesso percorso argomentativo seguito dalla Cassazione vi contrappone uguali argomentazioni ma di segno contrario.
E la conclusione del ragionamento del giudice di merito è che «va respinta una interpretazione che postuli un danno in re ipsa, contraria ad un costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il risarcimento dei danni scaturenti dal rapporto lavorativo – quale ad esempio il danno biologico o quello di perdita di chance – va provato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento e, quindi, anche attraverso la prova per presunzioni, sottoponendo alla valutazione del giudice precisi elementi in base ai quali sia possibile risalire attraverso un prudente apprezzamento alla esistenza dei danni denunziati (cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972 ed in precedenza Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006 n. 6572)». Riguardo alla compatibilità con i principi dell’UE, afferma che «il nostro sistema giuridico prevede, all’art. 36 del testo unico del pubblico impiego, il diritto al risarcimento del danno, oltre ad un accentuato regime di responsabilità dirigenziale, che assume un evidente contenuto dissuasivo al ricorso abusivo alla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato».
La sentenza del Tribunale di Velletri, benché susciti perplessità se la si guarda nell’ottica della tenuta del sistema giustizia e della architettura giurisdizionale, ha però il pregio di esplicitare le perplessità che suscita la sentenza delle SS.UU, anche se occorre dire che il giudice di Velletri non convince con la soluzione (in realtà non soluzione) proposta.
Si può ritenere che la Cassazione abbia introdotto nell’ordinamento un caso di danno in re ipsa?
A parere di chi scrive ciò, in realtà, non è avvenuto. Reiteratamente la Suprema Corte afferma nella sua decisione che la presunzione si applica «in chiave agevolativa dell’onere della prova». Nella prima parte della sentenza le SS.UU. illustrano quale sia la nozione di danno desumibile dall’art. 36, co. 5, d.lgs. 165/2001, richiamando l’art. 1223 del codice civile e soffermandosi soprattutto sul danno da «perdita di chance», individuato come il danno maggiore che il lavoratore può subire in tali casi. Insomma la Corte di legittimità nel suo ragionamento parte dalla considerazione che la norma positiva, da interpretare e non certo da sovvertire, richiede implicitamente ma ineludibilmente l’esistenza di un danno, perché si dia corso ad un risarcimento, poiché – come è stato giustamente sottolineato dal Tribunale di Velletri, e come di certo la Cassazione non ignora – nel nostro ordinamento, e precipuamente nel diritto del lavoro, non è prevedibile un onere risarcitorio in mancanza di danno. Tuttavia è giustissima la preoccupazione della Cassazione quando afferma che la prova di tale danno è sommamente difficile per il lavoratore, per cui, in chiave di interpretazione adeguatrice, si rende necessario sollevare il lavoratore da tale onere e, conseguentemente prevedere un criterio di risarcimento predeterminato – ovviamente, in mancanza di esatta individuazione del danno – da trasporre dalla disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 32, l. 183/2010, per i contratti privati. Sarebbe un grave errore (che forse il Tribunale di Velletri ha commesso) sottovalutare la complessità delle argomentazioni delle Cassazione a SS.UU., la quale ha reiteratamente ribadito giustamente che una interpretazione adeguatrice deve necessariamente muoversi «nel perimetro delle interpretazioni plausibili e non svincola del tutto il giudice dal dato positivo della norma interpretata». In caso contrario esiste solamente «l’incidente di costituzionalità». Quindi, e ovviamente, l’interpretazione adeguatrice non può giammai essere contra legem.
A questo punto rimane solamente una via per ricondurre la sentenza delle SS.UU. nel suo giusto alveo di decisione rispettosa sia dei dettami dell’UE, sia dei principi fondamentali informatori del diritto interno. Occorre considerare che “l’interpretazione in chiave agevolativa dell’onere della prova” altro non è che una ipotesi di inversione dell’onere della prova. Il lavoratore deve solo dimostrare la sussistenza di un contratto flessibile illegittimo, la cui illegittimità sia riconducibile ai principi posti dalla normativa europea, per ottenere il risarcimento del danno forfettizzato. Ma il datore di lavoro avrà la possibilità di provare che in concreto il lavoratore non ha subito alcun danno. Sicché la presunzione di danno non dovrà ritenersi assoluta, ma di natura tale da ammettere la prova contraria.
Possono citarsi dei casi concreti per spiegare come un tale assetto dei conflitti possa essere equilibrato. Si pensi per esempio ai tanti contratti flessibili stipulati dalla pubblica amministrazione in vigenza del blocco delle assunzioni. Quando è stato posto fine al blocco delle assunzioni sono state varate delle leggi di “stabilizzazione dei precari” della PA, per cui i lavoratori che erano stati assunti con contratti flessibili potevano godere alti punteggi nei concorsi per l’assunzione, tanto da essere stati assunti praticamente in massa. Orbene, in un tale caso, al lavoratore che ha dedotto in giudizio un contratto a tempo determinato illegittimo ai sensi della legge 368/2001, perché per esempio prorogato al di fuori delle ipotesi di legge, il datore di lavoro può opporre l’assoluta mancanza di danno. Infatti il lavoratore in tal caso, per effetto della stipulazione del contratto di lavoro, ha ottenuto un rilevante vantaggio, e di certo non un danno.
Una tale conclusione, oltre che rispettosa del diritto interno, è pienamente coerente con il diritto UE, per il quale l’inversione dell’onere della prova costituisce uno strumento efficace di tutela dei diritti dei cittadini e dei lavoratori (tra i tantissimi casi, basterà ricordare le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, che prevedono l’inversione dell’onere della prova in materia di discriminazioni nei luoghi di lavoro).
* Avvocato in Roma, Studio Legale Maresca, Morrico, Boccia e Associati

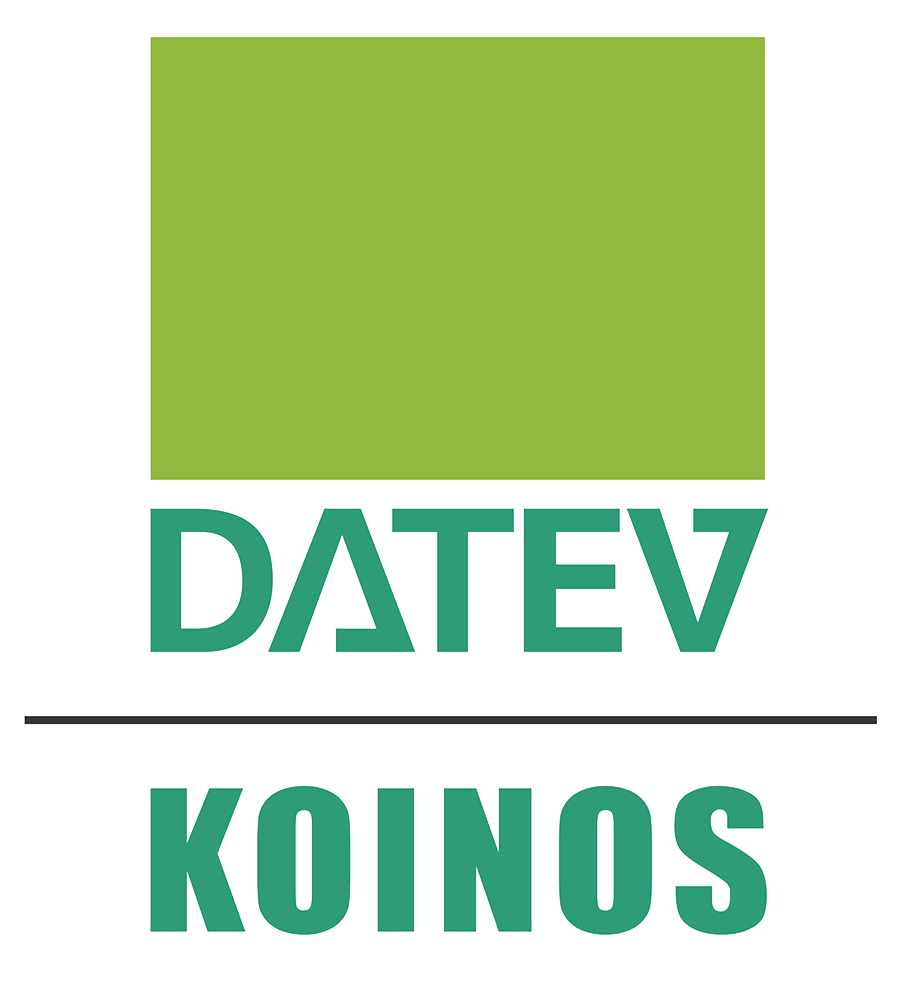






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!