Il previgente divieto di interposizione di manodopera, l’appalto e le nuove forme di datorialità
di Gaetano Giannì*
La storia del fenomeno della dissociazione tra titolarità formale del rapporto di lavoro ed utilizzazione della prestazione è stato contraddistinto per anni, anzi per decenni, da una evoluzione dolce, pur con qualche strappo non eccessivamente traumatico. L’intervento integratore della giurisprudenza ha dato sostanza alle tutele che l’ordinamento ha voluto approntare a difesa dei lavoratori, attraverso la individuazione concreta dei casi di interposizione e la conseguente applicazione dell’apparato sanzionatorio disposto dalla legge 1369/1960.La giurisprudenza di legittimità ha cercato di tenere conto di quanto e di come il mutare della realtà sociale, del sistema economico e delle tecniche di gestione dell’impresa richiedessero un adeguamento anche nell’interpretazione delle norme che regolavano la materia. Ma negli ultimi decenni, le repentine profonde trasformazioni del sistema produttivo, assecondate da interventi legislativi non sempre coordinati – con i quali si è cercato di governare tali processi – hanno scardinato il vecchio sistema di risoluzione dei conflitti e con esso il lungo equilibrio che si era instaurato tra le esigenze di tutela del prestatore di lavoro ed il riconoscimento delle ragioni dell’impresa. Un equilibrio certo complicato, problematico, come è, forse, normale che sia nell’ambito di questioni così rilevanti per il diritto del lavoro. Ma un equilibrio che si è mantenuto sulla stratificazione di principi interpretativi abbastanza condivisi, laddove, nelle singole fattispecie, a dividere era soprattutto la valutazione dei reali fatti portati in giudizio. Come si atteggia quindi il governo dei complessi processi che impongono ancora oggi di mediare tra le esigenze di un decentramento produttivo sempre più veloce ed esteso e le indispensabili tutele che debbono essere assicurate ai lavoratori coinvolti in tali processi? Le legge 1369 del 1960, come è noto, ha risposto ad esigenze di tutela molto avvertite nel particolare momento storico in cui è nata (era il periodo delle massicce migrazioni di lavoratori dal meridione, verso il Nord che si industrializzava). Il divieto contenuto nell’art. 2127 cod. civ., che salvava comunque gli effetti del contratto dell’interposto, non era più in grado di fornire una tutela veramente efficace contro lo sfruttamento di manodopera. La nuova legge prevedeva invece strumenti più incisivi, sia per l’accertamento dell’interposizione – si pensi alla presunzione contenuta nel terzo comma dell’art. 1 della legge – sia sotto il profilo sanzionatorio, poiché l’interponente doveva assicurare al lavoratore non più il rispetto del contratto stipulato con l’interposto, ma tutte le condizioni di un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’accertamento dell’interposizione nato dalla nuova legge è stato sempre governato dal principio di effettività: gli effetti del contratto di lavoro dovevano essere posti a carico dell’imprenditore che aveva effettivamente utilizzato le prestazioni (Cass. 1264/1982). Tuttavia, la dottrina giuslavoristica maggioritaria ha sempre attribuito alla disciplina in questione carattere sanzionatorio, fondato sull’applicazione automatica delle conseguenze stabilite dalla legge all’accertamento della deviazione dal modello legale. Una parte della dottrina giuslavoristica, invece, le cui analisi sembrano aver acquistato maggior peso nell’attuale quadro normativo, hanno interpretato la legge 1369/1964 come una disciplina esplicativa del principio di subordinazione sancito dall’art. 2094 cod. civ., per cui l’indagine del giudice avrebbe avuto come oggetto “l’accertamento” di chi sia stato nel caso concreto il “vero datore”. C’è ancora da dire che, a causa di una formulazione legislativa che avrebbe potuto ingenerare legittimi dubbi, la Suprema Corte a Sezioni unite ha affermato che il divieto di interposizione non si riferiva solamente al momento della stipula contrattuale, ma anche al momento successivo, della esecuzione del contratto di appalto (Cass. 851/1997). Molto interessante era la norma contenuta nell’art. 3 della legge, per la quale gli imprenditori negli appalti da eseguirsi all’interno delle aziende, con organizzazione e gestione propria dell’appaltatore, erano tenuti in solido con quest’ultimo a “corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti”. La norma era importante non solo perché la parità di trattamento veniva tutelata anche nei riguardi dei trattamenti normativi, ma anche perché tale forma di tutela veniva posta a carico del committente di un appalto che era legittimo. E’ appena il caso di notare che una simile garanzia, con l’abrogazione della legge 1369/1960 non è più sussistente in tema di appalti, mentre vige nel contratto di somministrazione (art. 23, d. lgs. 276/2003; ciò ha fatto parlare di possibile “dumping contrattuale”). Poiché la normativa in esame era destinata chiaramente a prevenire il fenomeno dell’interposizione cd. “di manodopera”, piuttosto che a governare processi di decentramento produttivo, la cui diffusione era ancora lontana, i criteri di accertamento dell’appalto legittimo, nei primi tempi di applicazione della disciplina, ponevano l’accento sulla natura genuinamente imprenditoriale dell’appaltatore, che veniva valutata sia in assoluto, sia con riferimento all’impiego di mezzi ed organizzazione, ed assunzione di rischio di impresa, nella fattispecie concretamente dedotta in giudizio (quindi con valore discretivo sempre fondato anche sulla nozione di appalto contenuta nell’art. 1655, cod. civ.). E’ coerente con tale contesto che la presunzione contenuta nel terzo comma dell’art. 1, legge 1369/1960 venisse reputata assoluta. La progressiva diffusione dei fenomeni di decentramento produttivo ha richiesto l’adozione di nuovi strumenti interpretativi. Nella realtà l’interposto poteva anche essere un “vero imprenditore”, mentre, secondo altra prospettiva, cominciava a diffondersi un modello economico di impresa che si affidava alla segmentazione produttiva per ridurre costi e flessibilizzare la produzione. L’indagine sulla liceità dell’appalto si arricchiva così di più estesi criteri di giudizio. Sono stati elaborati svariati indici rivelatori dell’interposizione, tesi sempre a dare concretezza al principio di effettività. Si è soffermata l’attenzione su chi abbia esercitato nella realtà i poteri direttivi ed organizzativi, propri dell’imprenditore; si è teorizzato il “potere di conformazione della prestazione”, ossia la capacità di imporre tempi ed oggetto della prestazione, nonché la nozione di “risultato produttivo autonomo”, riferito alla sussistenza di un effettivo oggetto ed agire imprenditoriale nell’attività dell’appaltatore. Quale naturale portato del decentramento produttivo dei servizi, si sono affermate nozioni di impresa e di appalto nelle quali la legittima sussistenza dell’elemento organizzativo poteva anche prescindere dal coordinamento “dei mezzi” materiali, potendosi evincere la natura imprenditoriale e la qualità genuina dell’appaltatore anche dalla mera organizzazione del lavoro. Nella prima fase di tale processo ha assunto estrema rilevanza la nozione di know how, quale bene immateriale capace di caratterizzare in modo decisivo le qualità di imprenditore e di legittimo appaltatore. Ed è proprio utilizzando la formidabile leva del know how che la giurisprudenza ha assestato alla legge 1369/1960 lo sconvolgimento interpretativo più consistente di tutta la sua vigenza, ribaltando il giudizio sulla presunzione contenuta nel terzo comma dell’art. 1 della legge, degradata a presunzione semplice in presenza di effettivo apporto di know how da parte dell’appaltatore (Cass. SS.UU. 10183/1990). Il revirement, se tale è possibile definirlo, è stato imposto dalla diffusione del fenomeno dell’informatizzazione delle aziende, soprattutto quelle di credito. La società di informatica progettavano ed elaboravano software di gestione complessi e provvedevano poi ad implementarli sugli hardware dei clienti. Pertanto, nella loro attività, utilizzavano “macchine e attrezzature fornite dall’appaltante”. Tuttavia non era certo possibile dubitare della legittimità di tali appalti di servizi. La diffusione del decentramento produttivo quindi, a tacere per brevità di indagine di quanto abbia inciso sulla disciplina di altri importanti istituti giuridici – quali per esempio la cessione del ramo di azienda – ha accelerato la riconsiderazione degli strumenti di indagine, necessari all’accertamento dell’appalto legittimo, ed ha anticipato i tempi rispetto al quadro normativo attuale, nel quale il legislatore ha esplicitamente enunciato che negli appalti labour intensive l’organizzazione dei mezzi necessari può anche risultare dalla mera organizzazione del lavoro (si anticipa così l’art. 29, d. lgs. 276/2003). Come è noto, il d. lgs. 276/2003 ha abrogato la legge 1369/1960, che, come si è visto, per oltre un quarantennio ha governato il complesso fenomeno della dissociazione tra titolarità formale del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni. Già con la legge 24 giugno 1997, n. 196, era stata introdotta nell’ordinamento la facoltà per l’imprenditore di “utilizzare” le prestazioni di lavoratori messi a disposizione da altro datore di lavoro, che li aveva assunti. Tuttavia al “lavoro temporaneo” poteva farsi ricorso solo nei casi tassativi previsti dalla legge, anche se veniva dato alla contrattazione collettiva un significativo potere di estensione di tali casi. Inoltre, l’esigenza di utilizzazione doveva sempre avere il carattere della temporaneità, dell’eccezione alla regola generale che non lo consentiva. Tali connotati, uniti al fatto che la disciplina del contratto di lavoro temporaneo conviveva con la vigenza del divieto di cui alla legge 1369/1960, ha fatto dire in via maggioritaria agli interpreti ed alla dottrina – nonostante qualche autorevole parere contrario – che il divieto di interposizione di mano d’opera fosse ancora pienamente operante, pur dopo l’istituzionalizzazione di una tale poderosa eccezione. Lo scenario è mutato con l’entrata in vigore del d. lgs. 276/2003. Questa volta è stato introdotto nell’ordinamento un principio generale di utilizzabilità delle prestazioni di lavoro da parte di un imprenditore che non fosse il datore di lavoro formale, subordinato alla sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo, a giustificazione dell’utilizzazione. Ovviamente, il reclutamento di personale da somministrare poteva (e può) essere fatto solo dalle agenzie a ciò autorizzate. Nella nuova fattispecie introdotta nel 2003, quindi, l’utilizzazione di dipendenti assunti da altri non è più prevista come straordinaria o eccezionale, e può anche essere riferita “all’ordinaria attività dell’utilizzatore” (con il recente d.l. 20 marzo 2014, n. 34, poi il ricorso alla somministrazione di lavoro è stato del tutto liberalizzato, e soggetto solamente ad un limite quantitativo e ad uno temporale). Nel contempo, l’art. 85 del d. lgs. 276/2003 ha abrogato espressamente ed integralmente tutta la legge 1369/1960. In tale contesto, prevedibilmente, all’indomani dell’entrata in vigore della cd. legge Biagi, è tornato d’attualità il dibattito sulla permanenza, nel nostro ordinamento, di un generale principio di divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro. L’esito di tale dibattito tuttavia sembra privo di conseguenze pratiche. L’interposizione di prestazioni lavorative è ancora un fenomeno attuale, per quanto abbia una consistenza socio economica certamente diversa da quella attuale nel 1960; e, come è noto, costituisce ormai una fattispecie legittima in taluni casi, come la somministrazione, o il distacco, che proprio con il d. lgs. 276/2003 ha finalmente conosciuto una specifica disciplina normativa. Indubbiamente oggi nell’ordinamento esistono norme generali e principi giuridici che non rendono più necessaria la vigenza di una normativa apposita di tutela dei lavoratori. Precisamente, l’art. 2094 e l’art. 1655 cod. civ. (quest’ultimo, integrato dal secondo comma dell’art. 29, d. lgs. 276/2003) delineano con sufficiente esaustività il campo di legittimità dell’appalto legittimo. Attraverso tali norme è possibile accertare la sussistenza di un appalto “genuino”, anche sotto il profilo giuslavoristico del rispetto delle tutele dei diritti dei lavoratori coinvolti, ossia nella prospettiva tradizionale della “saldatura del rapporto di lavoro all’organizzazione dei mezzi produttivi” (secondo la felice espressione di un noto Autore che si è occupato della materia). La fine del divieto di interposizione denota allora un quadro di rimedi generali contro gli appalti illegittimi che ha carattere meno sanzionatorio e più accertativo. Un apparato sanzionatorio, anche penale, ancora però sussiste nei casi di illegittima dissociazione tra datore di lavoro formale ed effettivo utilizzatore, e lo si trova nella disciplina della somministrazione e nella previsione della somministrazione irregolare e della somministrazione fraudolenta (rispettivamente artt. 27 e 28, d. lgs. 276/2003). Ci si chiedeva all’inizio di questo breve scritto come si atteggiasse oggi il governo dei complessi processi di terziarizzazione dell’economia che impongono la mediazione tra le esigenze di un decentramento produttivo sempre più veloce ed esteso e le indispensabili tutele che debbono essere assicurate ai lavoratori coinvolti in tali processi. La multiforme realtà produttiva, e l’evoluzione del modello economico, stanno mettendo in crisi la saldezza dei principi interpretativi che per un cinquantennio hanno egregiamente governato la materia. Negli appalti di servizi, per es. quelli di call center, si delinea un labile confine tra le “direttive” del datore di lavoro e le “istruzioni” del committente, i cui servizi ai clienti sono gestiti dai dipendenti dell’appaltatore. Esistono appalti (si pensi al cd. appalto – regia) nel quale il potere direttivo dell’appaltatore sui propri dipendenti è ridotto al minimo. Nell’appalto in house – quello previsto dall’art. 218 del codice degli appalti, d. lgs. 163/2006 – viene considerato legittimo l’affidamento di un servizio da parte di una società controllante ad una controllata al 100%, che opera in regime di monocommittenza, o quasi, con evidente necessità di riconsiderare in tale ambito la nozione di rischio di impresa. Esistono contratti, quali quelli relativi alle reti di impresa, in cui è possibile disciplinare contrattualmente la codatorialità dei lavoratori. Possiamo fermarci solamente a tali esempi estremi per rendere l’idea di quanto una indagine non prevenuta sulla “genuinità” di un appalto debba oggi ritenersi complessa e persino sfuggevole, sotto il profilo dei criteri di indagine da utilizzare. E probabilmente anche per tale motivo, nella consapevolezza della difficoltà (o della inutilità, considerando il favore dell’ordinamento per il decentramento produttivo) di individuare il datore cui assoggettare gli oneri legali e contrattuali inerenti ai diritti del prestatore, che il legislatore ha avviato da anni un processo che disegna tutele indifferenti all’indagine sul “vero datore”, e pone invece uno statuto di diritti a carico di tutti i soggetti che interferiscono con l’attività del prestatore, o ne percepiscono l’utilità. In tale direzione possono leggersi le norme in materia di responsabilità solidale tra committente ed appaltatori e subappaltatori, ex art. 29, d. lgs. 276/2003, nonché quelle previste dalla legge 248/2006 (art. 35, co. 28, relativo al versamento delle ritenute fiscali e gli oneri assicurativi sui redditi di lavoro); ed ancora, si considerino le norme sulla responsabilità del committente in materia di sicurezza (art. 26, d. lgs. 81/2008); l’operatività della responsabilità solidale anche in materia di danno cd. differenziale, ai sensi dell’art. 7, d. lgs. 626/1994. In tutti tali casi, ma altri se ne potrebbero citare, nel tempo il legislatore ha ampliato l’ambito oggettivo e soggettivo delle responsabilità, iniziando ad instaurare, come efficacemente sostenuto di recente da un brillante Autore, un sistema che “nella determinazione del concetto di datore di lavoro” ha visto spostarsi l’enfasi “dalla centralità dell’utilizzazione del lavoro alla valorizzazione della condivisione delle responsabilità”.
*Avvocato giuslavorista del Foro di Roma

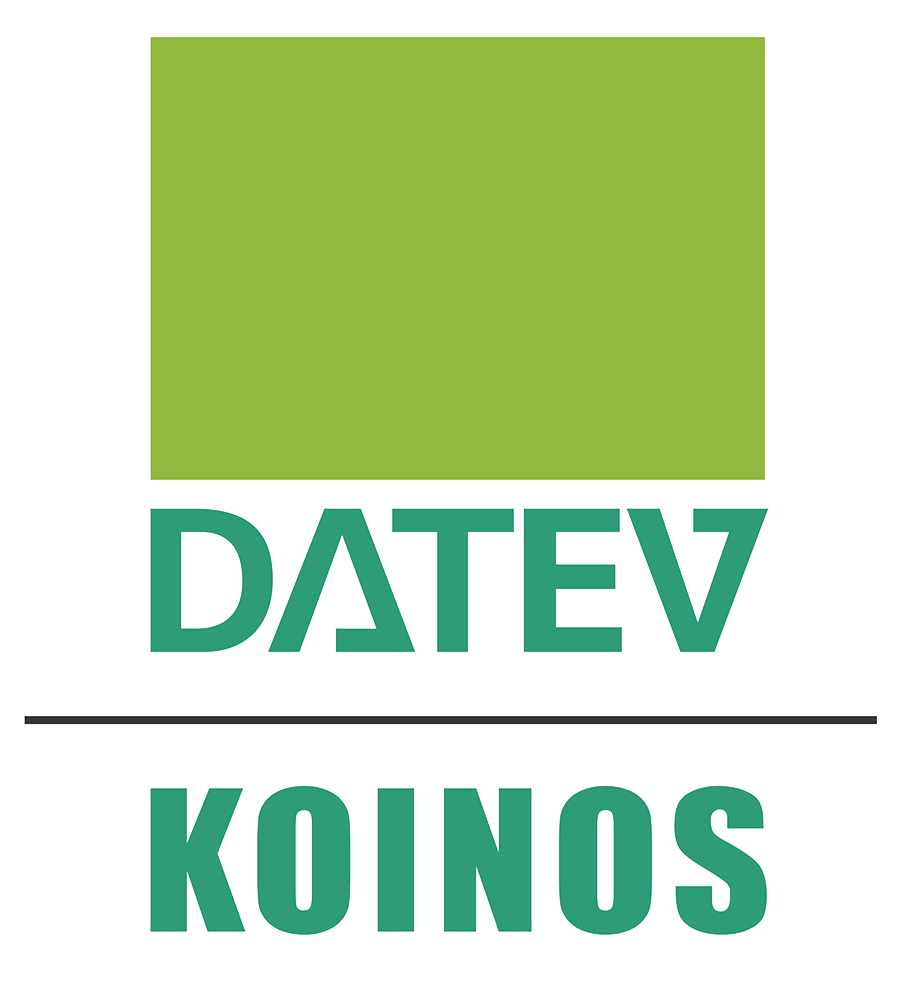






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!