La libertà di opinione e il divieto di indagine: l’evoluzione in 50 anni di statuto dei lavoratori
di Giada Rossi *
Il giorno 20 maggio 2020 la legge 300 del 1970, meglio nota come Statuto dei Lavoratori, ha compiuto cinquant’anni, confermandosi, a distanza di mezzo secolo, la norma cardine a tutela dei diritti, della libertà e della dignità della persona del lavoratore nonché dell’attività sindacale.
Lo Statuto dei lavoratori ha avuto il merito di istituzionalizzare il ruolo del sindacato all’interno dell’impresa, sancendone ufficialmente l’ingresso e regolamentandone la presenza, tanto in un’ottica garantistica, a difesa dei diritti individuali dei lavoratori nonché delle prerogative sindacali, che promozionale della stessa attività sindacale. Il sindacato ha ottenuto dunque un riconoscimento del suo ruolo fondamentale come attore nelle relazioni industriali e come parte fondamentale, anche ai tavoli istituzionali, del dialogo nella disciplina dei rapporti di lavoro.
Circa i rapporti individuali, la normativa vincolante di cui allo Statuto dei Lavoratori è tesa a contemperare le esigenze del datore di lavoro e del prestatore di lavoro, limitando i poteri del primo o le modalità di esercizio degli stessi, valorizzando i valori della libertà, della dignità umana e della sicurezza, di rango costituzionale.
I datori di lavoro si sono scontrati con una disciplina limitativa del loro potere di indagine e di controllo, contrapposta a quegli interessi del lavoratore meritevoli di tutela, in primis alla riservatezza, che solo pochi anni dopo l’entrata in vigore dello Statuto, la Corte Costituzionale, con la nota pronuncia n. 38 dell’anno 1973, ha qualificato come diritto fondamentale dell’individuo.
La riservatezza e la dignità trovano infatti tutela nei primi articoli dello Statuto, tra i quali spiccano l’art. 1 sulla libertà di opinione e l’art. 8 sul divieto posto in capo al datore di lavoro di effettuare indagini sulle opinioni, anteriormente all’assunzione ovvero in costanza di rapporto.
Da un lato quindi viene sancita la libertà, rectius il diritto, per il prestatore di lavoro di manifestare il proprio pensiero, purché nel rispetto della Costituzione e della disciplina dello Statuto; dall’altro viene preclusa alla parte datoriale la possibilità di effettuare indagini su opinioni politiche, religiose, sindacali o comunque su aspetti estranei all’attitudine professionale.
La libertà di opinione di cui all’art. 1 della legge 300/70 riafferma il diritto fondamentale della persona, di rango costituzionale, di manifestare il proprio pensiero (art. 21 Cost.), garantendone l’esercizio anche nella sede di lavoro.
Questa norma di apertura non deve essere tuttavia interpretata come una mera ripetizione, una ridondante enunciazione di un principio dato per presupposto; essa costituisce invece la diretta applicazione di quanto previsto dall’art. 2 della Carta Costituzionale, secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e tra queste ultime non può che annoverarsi proprio il luogo di lavoro.
Non si possono sul punto trascurare precedenti giurisprudenziali, anteriori all’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori, che avevano giudicato legittime le infrazioni disciplinari intimate a lavoratori per aver distribuito materiale sindacale durante pause dal lavoro (rif. Cass. 425/1967).
La rimozione di qualsiasi ostacolo alla manifestazione del pensiero, come estrinsecazione della personalità umana, anche sul luogo di lavoro, senza limitazioni originate da credi politici, religiosi o sindacali, trova piena attuazione nel successivo art. 14 dello Statuto, che introduce il diritto di costituire associazioni sindacali nei luoghi di lavoro e di aderirvi.
Al lavoratore è dunque riconosciuto il pieno diritto di manifestare il proprio pensiero nonché, nell’ambito strettamente sindacale, di promuovere, aderire, organizzare e partecipare attivamente alle relative attività. Alla libertà di manifestazione del pensiero si accompagna, quale diritto eguale e contrario, quella di non manifestazione dello stesso, quindi il diritto alla riservatezza circa le proprie convinzioni ideologiche. Non solo è dunque precluso al datore di lavoro di pretendere la divulgazione di queste ultime da parte del personale dipendente, ma una precisa disposizione, l’art. 8 dello Statuto, vieta ogni sorta di indagine a ciò volta.
L’art. 8 sancisce infatti il divieto per il datore di lavoro di effettuare indagini sulle opinioni, direttamente o a mezzo di terzi, tanto ai fini dell’assunzione quanto nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro. Tale divieto non abbraccia solo le opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, ma altresì qualsiasi aspetto non rilevante ai fini della valutazione dell’attitudine professionale dello stesso.
La ratio della norma era scoraggiare la diffusa pratica della schedatura del personale e limitare quindi il potere di controllo del datore di lavoro, aspetto precedentemente mai normato, salvaguardando così la sfera privata del prestatore di lavoro.
Le tutele faticosamente conquistate e sancite con l’entrata in vigore della legge 300/70, sembrano tuttavia oggigiorno vanificate dalla diffusione, spesso sottovalutata, di informazioni personali mediante l’utilizzo di social media, blog o applicazioni di messaggistica, che consentono una vera e propria profilazione della persona del lavoratore, anche su tematiche sensibili quali orientamenti politici, religiosi o sessuali.
Le medesime piattaforme vengono poi sovente scambiate dagli utenti stessi come luoghi sicuri in cui poter esternare ogni pensiero, critica o sfogo, noncuranti delle conseguenze.
Sempre più frequentemente sono portate avanti alle Corti vertenze aventi ad oggetto critiche o offese di lavoratori nei confronti di colleghi, di superiori gerarchici o della stessa impresa, sfociate in procedimenti disciplinari e, talvolta, in una sanzione espulsiva.
L’esercizio del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, che trova tutela nel dettato costituzionale e statutario, incontra due limiti: di continenza sostanziale (che i fatti affermati siano veri) e formale (che i medesimi fatti non ledano l’onore delle persone, secondo il comune apprezzamento).
Il disvalore che viene socialmente attribuito a determinate espressioni è oggetto di continua evoluzione e le Corti sono chiamate di volta in volta a valutarne l’effettiva portata lesiva (con esiti talvolta contrastanti, ove epiteti sostanzialmente equivalenti vengono talvolta giudicati idonei a fondare un provvedimento disciplinare, talaltre no).
In ogni caso, l’offesa reputazionale, una volta accertata, è considerata valido motivo financo di licenziamento, a prescindere dal mezzo utilizzato, inclusi social network.
Significativo il caso all’attenzione della Corte d’Appello di Torino nella pronuncia n. 599/2017, poi confermata dalla Suprema Corte, nella quale è stato confermato il licenziamento intimato ad un lavoratore che aveva pubblicato offese al datore di lavoro sulla propria bacheca virtuale del social media Facebook.
In tale caso, la conoscenza delle circostanze fondanti gli addebiti disciplinari era avvenuta mediante soggetto terzo, a cui era visibile il profilo del lavoratore.
Il dipendente aveva invocato la violazione dell’art. 8 dello Statuto, quindi la violazione della sua sfera privata, essendo il profilo in questione non pubblico, ma visibile ai soli contatti rientranti negli amici, ovverosia soggetti autorizzati alla visualizzazione dei post pubblicati.
Il datore di lavoro si era difeso affermando che la visione del profilo, per il tramite soggetto terzo, non era avvenuta con lo scopo di indagare le opinioni del lavoratore, ma al fine di accertare comportamenti lesivi del dovere di correttezza e fedeltà facenti capo a quest’ultimo.
La Corte ha rilevato la potenzialità diffusiva del messaggio, nonostante appartenente a profilo privato, in virtù dell’astratta possibilità di essere replicato, condiviso e quindi diffuso a soggetti estranei, confermando pertanto la legittimità della sanzione disciplinare originata dal post pubblicato dal lavoratore.
Nel medesimo senso si rinvengono pronunce aventi ad oggetto post denigratori diffusi a mezzo Twitter.
In senso contrario, si sta diffondendo un orientamento più restrittivo, secondo il quale, quando i profili utilizzati non siano pubblicamente visibili a qualunque utente del social media, quindi le affermazioni siano destinate ad una cerchia ‘ristretta’ di utenti, il commento oggetto di post deve essere considerato come un esercizio della libertà di espressione, al pari di una conversazione privata.
Secondo questo orientamento, un profilo social configurerebbe un luogo di discussione privato, pertanto soggetto alle tutele costituzionali di libertà e segretezza della corrispondenza.
In tali pronunce è stato dunque escluso il diritto ad avvalersi di simili prove onde legittimare un procedimento disciplinare a carico del prestatore di lavoro o, quantomeno, è stata ridimensionata la portata offensiva di tali commenti, con un sindacato sulla proporzionalità delle sanzioni inflitte (rif. ex multis Cass. 21695/2018; Cass. 2449/17).
Accanto a casi di offese o critiche direttamente rivolte ai datori di lavoro, sempre più frequentemente stanno assumendo rilevanza disciplinare commenti o post di lavoratori dipendenti dal contenuto discutibile, ma comunque estraneo al contesto aziendale.
Ne sono un esempio commenti violenti, razzisti o sessisti che talvolta vanno a scontrarsi con i valori aziendali o con il sentire comune. Numerose imprese hanno scelto di adottare codici etici e policy di comportamento e altre ancora di sostenere iniziative nel sociale e nel volontariato, creando una immagine virtuosa dell’impresa, non meramente interessata all’utile, ma anche al bene comune.
Potrebbe pertanto fondare una contestazione disciplinare un post o un commento contrario ai valori fatti propri dall’azienda, sia per un danno all’immagine di quest’ultima, sia per una lesione del vincolo fiduciario con il singolo lavoratore che abbia pubblicamente denigrato tali valori.
Sul tema, mancano tuttavia per il momento orientamenti consolidati.
In generale, è comunque possibile constatare come si stia sempre più affermando la distinzione fra profili o piattaforme pubblici, ove dunque la diffusione di messaggio è astrattamente idonea a raggiungere una vasta e non controllabile platea di fruitori, e profili privati, equiparati spesso ad un luogo riservato, come potrebbe essere una cerchia (più o meno ampia) di amici, ove ogni commento, sebbene denigratorio, sarebbe tutelato dal diritto alla riservatezza e alla privacy, oggigiorno sempre più percepito come un valore da proteggere e valorizzare.
*Avvocato in Milano

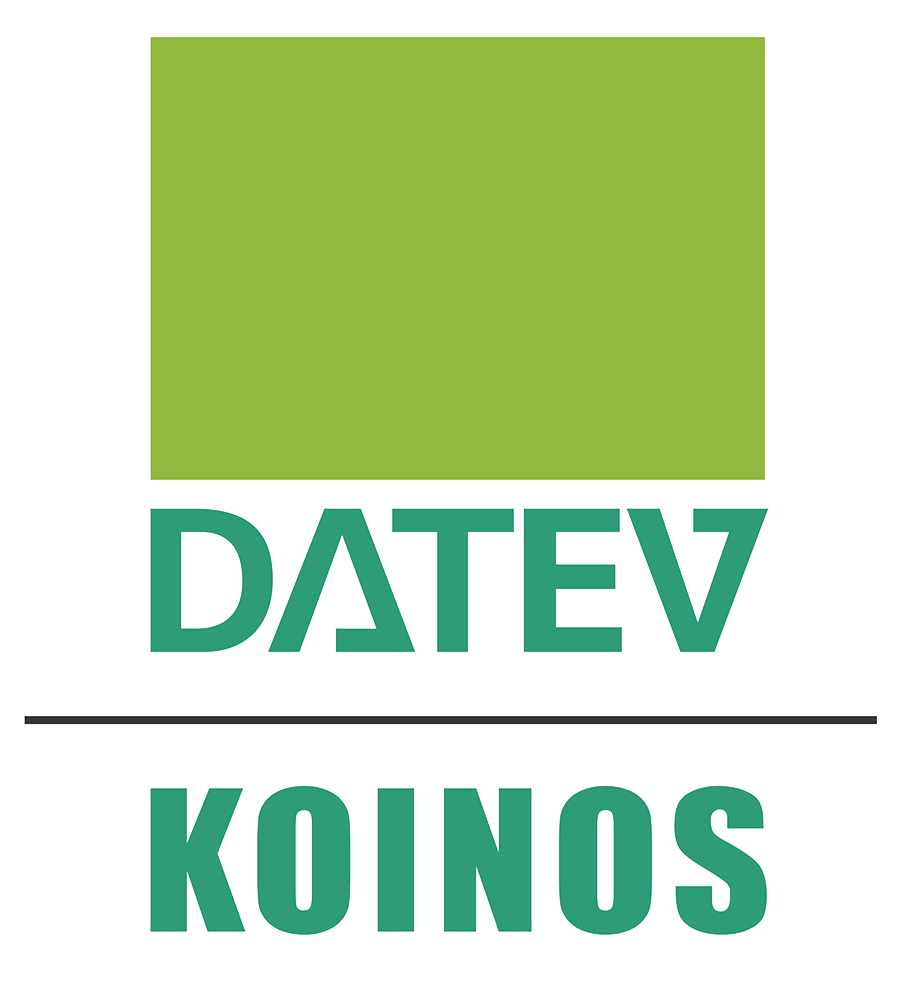






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!