L’estensione giurisprudenziale delle tutele per i rider
di G. Maurizio Ballistreri*
introduzione
La Corte di Cassazione è di recente intervenuta con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio scorso su un tema controverso in dottrina e in giurisprudenza del diritto del lavoro: la qualificazione del rapporto dei cosiddetti “rider” [1].
La sentenza della Suprema Corte, a seguito di un ricorso di Foodora, il colosso multinazionale tedesco della consegna dei pasti a domicilio, contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino, la n. 26 del 4 febbraio 2019[2], con cui pur non accogliendo la domanda di riconoscimento da parte dei rider ricorrenti della fattispecie della subordinazione, ha ritenuto applicabile a tale rapporto l’art. 2 del d.lgs n. 81 del 2015 e il conseguente diritto alla corresponsione della retribuzione prevista per i lavoratori dipendenti inquadrati al V livello del Ccnl della “Logistica trasporto merci”.
il contrasto giurisprudenziale
Con sentenza n. 1853 depositata il 10 settembre 2018, il Tribunale di Milano – confermando un precedente orientamento del Tribunale di Torino – con la sentenza 7 maggio 2018, n. 778, ha definito come non subordinata l’attività dei rider: “Nel rapporto di lavoro tra una multinazionale del food delivery e il rider, il fatto che il lavoratore possa stabilire la quantità e la collocazione temporale della prestazione, i giorni di lavoro e quelli di riposo, e il loro numero, rappresenta un fattore essenziale dell’autonomia organizzativa, incompatibile con il vincolo della subordinazione (nel caso di specie, il rider non aveva vincoli di sorta, in fase di prenotazione degli slot, nella determinazione dell’an, del quando e del quantum della prestazione)” [3].
Il Tribunale di Torino, a sua volta, il 7 maggio 2018 con sentenza n. 718, aveva rigettato la richiesta del riconoscimento di un rapporto di subordinazione di alcuni rider con Fodora, affermando, tra l’altro, che: “La determinazione del luogo e dell’orario di lavoro non veniva imposta unilateralmente dall’azienda che si limitava a pubblicare su Shiftplan gli slot con i turni di lavoro; i ricorrenti avevano la piena libertà di dare o meno la propria disponibilità per uno dei turni indicati dall’azienda. La verifica della presenza dei riders nei punti di partenza e dell’attivazione del loro profilo sull’applicazione rientra a pieno titolo nell’ambito del “coordinamento” perché è evidente che Foodora aveva la necessità di sapere su quanti riders poteva effettivamente contare per le consegne, anche in considerazione del fatto che un non trascurabile numero di lavoratori dopo l’inserimento nel turno non si presentava a rendere la prestazione senza alcuna comunicazione preventiva” [4].
Nei fatti i Tribunali del Lavoro di Milano e Torino si sono pronunciati[5] nel solco della giurisprudenza consolidata sulla fattispecie[6], non riprendendo, invece, i caratteri di innovazione ermeneutica in materia di subordinazione, della “storica” sentenza del Pretore di Milano del 20 giugno 1986 sui cosiddetti “Pony express”[7], che apriva le porte della giurisprudenza a quel fenomeno che la dottrina ha illustrato come “detipicizzazione della subordinazione”[8] . D’altronde, non si può non evidenziare quanto elaborato dalla dottrina circa l’impossibile difesa di un modello unitario di lavoro dipendente, con la disarticolazione della fattispecie della subordinazione, la quale non presenta più connotati di uniformità[9].
Ma l’11 gennaio 2019 la Corte d’Appello di Torino, chiamata a pronunziarsi sul ricorso di alcuni dei rider di Foodora avverso la citata sentenza 7 maggio 2018, n. 778 del Tribunale del Lavoro, che ne aveva declarato la soccombenza, non riconoscendo il carattere subordinato alla prestazione da essi svolta, ha invece statuito, secondo la previsione dell’art. 2 del d.lgs n. 81/2015 (c.d. “Jobs Act”)[10]: “il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione all’attività lavorativa da loro effettivamente prestata in favore di Foodora sulla base della retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del quinto livello del contratto collettivo logistica-trasporto merci dedotto quanto percepito”, con un’equiparazione de facto dei rider a dei fattorini con contratto di lavoro alle dipendenze.
La sentenza della Corte d’Appello di Torino deve essere letta però, non solo in rapporto all’art. 2 del d.lgs n. 81/2015, ma anche nel solco degli orientamenti della più recente giurisprudenza di Cassazione sul punto, che ha utilizzato il criterio dell’etero- organizzazione per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo[11].
La sentenza della cassazione n. 1663/20 del 24 gennaio 2020 sui rider
Sul contrasto giurisprudenziale verificatosi, la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 1663/20 del 24 gennaio 2020, rigettando il ricorso di Foodora nei confronti dell’avvenuto riconoscimento dell’applicabilità alla fattispecie litigiosa dell’art. 2 del d.lgs n. 81/2015 (c.d. “Jobs Act”) e, quindi, ribadendo il diritto dei lavoratori appellati alla corresponsione della retribuzione prevista per i dipendenti inquadrati al V livello del CCNL della “Logistica trasporto merci”.
Tale statuizione, secondo la Cassazione, in ragione della utilizzazione prevista nella prefata norma della nozione di etero- organizzazione “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” e, quindi, per le prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative come quelle dei rider. Un’impostazione della Suprema Corte sulla fattispecie, che ha suscitato primi dissensi in campo dottrinale[12].
Secondo la Cassazione, il coordinamento tra le parti, definito consensualmente nei casi di para-subordinazione, nella fattispecie è determinato dall’esterno, configurandosi, quindi, come “etero-organizzato” nella fase funzionale e di esecuzione, da cui la sua necessaria riconduzione alla previsione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs n. 81 del 2015. Non vi è dubbio che tale operazione ermeneutica della Suprema Corte apre una nuova prospettiva alla necessaria ridefinizione dei confini tra subordinazione e autonomia, imponendo alla politica del diritto l’esigenza di individuare una soglia minima uguale di tutele per tutte le tipologie di lavoro, a prescindere dalla loro qualificazione formale.
*Professore di diritto del lavoro nell’Università di Messina
- In “LavoroDirittiEuropa” newsletter n°9 – La Corte di cassazione in materia di riders/ciclofattorini sentenza n.1663 del 24 gennaio 2020, 24.01.2020.
- Corte d’Appello di Torino n. 26 del 4 febbraio 2019, in giuslavoristi.it del 5.02.2019.
- Tribunale di Milano, sentenza n. 1853 depositata il 10 settembre 2018. Il ragionamento seguito dai giudici di merito ha individuato i seguenti aspetti:
- Nella app installata sul suo cellulare, il prestatore può indicare la propria disponibilità, in termini di zona, di orario e di giornate;
- Il prestatore può accettare o meno la consegna senza che sussiste un numero minimo di accettazioni;
- Il rifiuto o la mancata accettazione ed un giudizio negativo del cliente hanno come conseguenza soltanto una eventuale restrizione circa la fascia oraria;
- La fissazione di limiti standard e di istruzioni circa il contenuto della prestazione sono pur sempre riferibili all’area dell’autonomia;
- Non sussiste alcun potere disciplinare sulla falsariga prevista dall’art. 7 della legge n. 300/1970 in quanto, il sistema dei punteggi non dà luogo a sanzioni di natura afflittiva ma soltanto ad una rimodulazione delle modalità organizzative che non mettono in discussione la possibilità di scegliere i giorni e le ore per le prestazioni;
- Non si configura la c.d. etero organizzazione prevista dall’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015 per la riconduzione al lavoro subordinato, in considerazione che, a monte, sussiste sempre la volontà del prestatore di aderire o meno all’invito comunicato con l’applicazione sul cellulare;
- Gli indici sussidiari per valutare la subordinazione (continuità della prestazione, assenza di rischio, inserimento nella struttura aziendale, orario di lavoro) non appaiono significativi al punto tale da determinarne la sussistenza.
- Il Tribunale di Torino ha ribadito che “Sono innumerevoli le sentenze che si sono occupate della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, ma il criterio principale elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione è quello secondo cui “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato – ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo – il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative ” (tra le tante, Cass. 8.2.2010 n. 2728)… Si tratta di un profilo che era stato già messo in rilievo dalla Corte di Cassazione tanti anni fa, quando si era pronunciata in merito a una vicenda che presentava una certa analogia con quella attuale perché riguardava la consegna di plichi effettuata da lavoratori qualificati come autonomi: la Corte aveva allora affermato che proprio la “non obbligatorietà” della prestazione lavorativa escludeva in radice la subordinazione perché “la configurabilità della “eterodirezione ” contrasta con l’assunto secondo cui la parte che deve rendere la prestazione può, a suo libito, interrompere il tramite attraverso il quale si estrinseca il potere direttivo dell’imprenditore “ (Cass. 7608/1991 e 811/1993).
- Secondo i giudici dei Tribunali di Milano e Torino le parti hanno voluto dar vita a un rapporto di lavoro autonomo, sia pure a carattere coordinato e continuativo, e in questa prospettiva legale hanno confermato la più tradizionale nomofilachia di legittimità, anche recente, costante su tale fattispecie (ex pluribus Cass. 19.8.2013 n. 19199; Cass. 8.4.2015 n. 7024; Cass. 1.3.2018 4884 “ai fini della determinazione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero avere simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia”.
- Si veda Trib. Milano 10 ottobre 1987, in “Rivista Italiana di Diritto del Lavoro”, 1987, II, 688, con nota di Ichino, P.
- Milano 20 giugno 1986, in “Rivista Italiana di Diritto del Lavoro”, 1987, II, 70, con nota di Ichino, P., Libertà formale e libertà materiale del lavoratore nella qualificazione della prestazione come autonoma o subordinata; v. anche Pret. Pen. Milano 27 aprile 1987, in “Lavoro 80”, 1987, p. 1025, con nota di Chiusolo, S., Il lavoro subordinato e le nuove forme di organizzazione del lavoro.
- Perulli, A., Costanti e varianti in tema di subordinazione e autonomia, in “Lavoro e Diritto”, 2, 2015, p. 262
- Mengoni, L., Introduzione in Autonomia e subordinazione nelle nuove figure professionali e del terziari, Atti del Convegno organizzato a Milano il 10 ottobre 1987, (a cura di Deodato, G-Siniscalchi, E.), Giuffré, Milano, 1988, in cui l’A. disegna già al tempo le innovazioni di sistema a cui il diritto del lavoro deve fare fronte: “la subordinazione non si presenta con connotazioni uniformi, questo è un segno della transizione, anche nella nostra materia, dal concetto tradizionale di sistema di tipo assiomatico, di sistema lineare o a catena ad un concetto nuovo, più elastico, più adatto ai bisogni della società che è quello di sistema a rete o sistema circolare che mai si chiude definitivamente, se quindi disposto a ricevere e trasformare nelle proprie strutture concettuali le istanze del mondo vitale” p. 18.
- 2 del d.lgs. n. 81/2015: “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
- Si veda a tal proposito la sentenza della Cassazione n. 3594/11, relativa all’utilizzazione di un consulente fiscale nello studio di un professionista, secondo cui “la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione all’intensità dell’etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente da quelle dello stesso studio” (nella stessa prospettiva Cass. 9894/05 e Cass. 27138/13).
- Ichino, P., La sentenza n. 1663/2020 attribuisce al Jobs Act un effetto sul lavoro dei rider pressoché identico a quello del decreto del governo M5s-Lega, col rischio di conseguenze incompatibili con questa forma di organiz n “newsletter.pietroichino.it”, 27.01.2020.

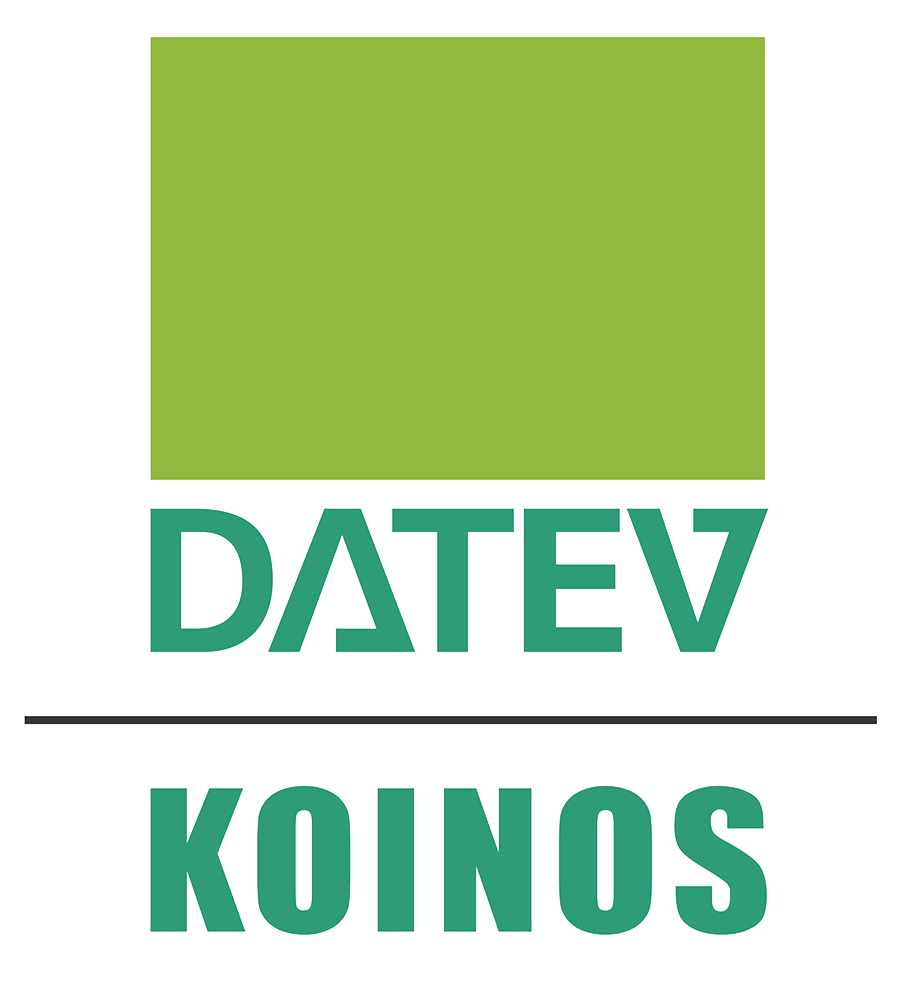






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!