Previdenza Complementare e pignorabilità in fase di accumulo, qualcosa sta cambiando?
di Giada Rossi*
All’interrogativo circa la possibilità di procedere a pignoramento di somme confluite in un fondo di previdenza complementare la risposta è stata per lungo tempo, e senza incertezza alcuna, negativa per quanto attiene la fase di accumulo.
La norma cardine è l’art. 11 comma 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” che prevede l’intangibilità della posizione di previdenza complementare durante tale fase; la stessa prosegue precisando i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni pensionistiche in capitale e rendita o delle anticipazioni per spese sanitarie e statuisce infine l’assenza di vincoli di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità per le somme oggetto di riscatto totale o parziale o negli altri casi di anticipazione.
La disciplina degli accumuli previdenziali complementari o facoltativi viene dunque mutuata da quella degli accumuli previdenziali obbligatori, così favorendo e tutelando la finalità sociale del risparmio previdenziale.
In caso di pignoramento notificato ad un fondo di previdenza complementare, la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c., dunque relativa ad eventuali somme dovute al debitore esecutato, ha di norma ad oggetto l’intangibilità in fase di accumulo di quanto ivi confluito, anche a titolo di quote di TFR. Per contro, in caso di richiesta di prestazione da parte dell’iscritto, il terzo rende dichiarazione positiva, precisando l’eventuale limite di pignorabilità.
In un contemperamento del diritto al risparmio previdenziale e di tutela delle pretese creditorie di terzi, queste ultime sono quelle che dunque risultano maggiormente sacrificate.
Ciononostante, una recente ordinanza della Suprema Corte ha messo in evidenza la fallacità di questo automatismo.
Nella vicenda di un dipendente del MIUR ancora in servizio, la cui indennità di fine servizio dovuta dall’Indap (successivamente dall’Inps) era stata sottoposta a pignoramento, veniva richiesto l’accertamento dell’obbligo del terzo, stante la mancata comparizione di quest’ultimo.
Il Giudice di prime cure si esprimeva favorevolmente, ma, in appello, la Corte di Bari dichiarava l’inefficacia del pignoramento in virtù di un’asserita impignorabilità di somme non ancora esigibili.
Portata la vicenda all’attenzione della Suprema Corte, quest’ultima, richiamando i propri consolidati orientamenti in punto di indennità di fine rapporto, tanto di dipendenti pubblici che privati, e della loro pignorabilità, ha di fatto riaperto la strada a nuove soluzioni, favorendo il confronto dottrinale sul tema.
Nell’ordinanza n. 19708 del 25 luglio 2018 viene in primis richiamato l’orientamento ormai consolidato secondo il quale le quote accantonate di TFR sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura; esse rappresentano un diritto certo e liquido, rispetto al quale la cessazione dell’attività lavorativa determina solo l’esigibilità.
Basti sul punto richiamare la pronuncia della Suprema Corte n. 4933 del 1989 in tema di disciplina del trattamento di fine rapporto dettata dall’art. 2120 c.c. nella nuova formulazione introdotta dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297.
è ivi infatti enunciato che nel nuovo sistema la somma spettante al prestatore di lavoro alla cessazione del rapporto non è più costituita da una quota dell’ultima retribuzione, aumentata proporzionalmente agli anni di servizio, ma è rappresentata dalla somma degli accantonamenti contabili (opportunamente rivalutati) di una quota aggiuntiva della retribuzione percepita dal lavoratore nel corso del rapporto.
A differenza dell’indennità di anzianità che non era liquida né esigibile prima della cessazione del rapporto, il trattamento di fine rapporto è liquido anno per anno, anche se la sua esigibilità è rinviata alla cessazione del rapporto.
E che di un diritto certo e liquido si tratti è dimostrato dal fatto che la legge definisce espressamente quella da accantonare come «quota aggiuntiva della retribuzione» e cioè come quota maturata insieme alla retribuzione; che parla espressamente di accantonamento progressivo (anche se puramente nominale) delle quote annuali dovute; che prevede una rivalutazione di esse, possibile solo se il credito è determinato nel suo preciso ammontare; che assicura il pagamento di dette somme mediante un fondo di garanzia; che stabilisce infine la possibilità per il lavoratore, in presenza di determinate circostanze, di attingere, durante il rapporto di lavoro, a detto accantonamento, mediante una richiesta di anticipazione sul trattamento fino a quel momento maturato […].
In forza del disposto dell’art. 553 c.p.c., i presupposti per l’assoggettabilità di un credito a pignoramento coincidono con la certezza dello stesso nonché con la sua liquidità (o liquidabilità secondo parametri oggettivi); del tutto ininfluente la esigibilità dello stesso, che invece determina semplicemente la possibilità di dare esecuzione all’ordinanza di assegnazione.
Nel panorama giurisprudenziale non mancano peraltro pronunce che, in generale, ammettono procedure espropriative presso terzi aventi ad oggetto crediti non esigibili o condizionati.
Si deve dunque concludere per la pignorabilità del TFR e per la necessità che le somme accantonate a tale titolo siano incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c. (vedasi sul punto Cass. 1049/98) che sancisce: la dichiarazione del terzo rileva in quanto diretta a completare il pignoramento, mediante l’esatta individuazione del suo oggetto (inizialmente indeterminato) e a realizzare l’indisponibilità del credito impedendone l’estinzione per atti volontari successivi; data tale funzione, la costante giurisprudenza afferma che la esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell’espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell’esecutato, cosicché l’espropriazione (presso terzi) può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione (ammettendosi così il pignoramento di crediti costituiti dal corrispettivo di un rapporto di lavoro non ancora maturati all’epoca del pignoramento: in questo senso Cass. 4 dicembre 1987 n. 9027; cfr. anche Cass. 22 giugno 1972 n. 2055, 26 settembre 1979 n. 4970).
Tale principio non è stato scalfito dalle riforme che hanno interessato le indennità di fine rapporto né dalla previsione di trattamenti differenziati del TFR, che può essere mantenuto in azienda oppure essere devoluto al Fondo di Tesoreria dello Stato costituito presso l’Inps nei casi di aziende sopra i cinquanta dipendenti.
Del pari, tale principio deve ritenersi oggi applicabile senza distinzioni tanto all’impiego pubblico che privato, stante l’equiparazione delle posizioni a seguito delle pronunce di incostituzionalità relative all’originario regime di impignorabilità del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (rif. Corte Cost. nn. 99/1993 e 225/1997).
L’ordinanza in commento prosegue poi nell’esame della natura del trattamento di fine rapporto, ricordando che corrisponde ad un credito che il lavoratore man mano matura nel corso del rapporto lavorativo, la cui corresponsione è meramente posticipata alla risoluzione del rapporto.
L’accantonamento del TFR, in azienda, presso il fondo di Tesoreria o ancora presso un fondo di previdenza complementare, non può alterarne la natura e la funzione.
Non va trascurata inoltre la possibilità che le somme accantonate siano oggetto di un anticipo in favore del lavoratore, facoltà concessa per legge dall’art. 2120 c.c. e dai Ccnl, ad esempio in virtù di particolari esigenze quali l’acquisto della prima casa o spese sanitarie etc. Allo stesso modo, i fondi pensione prevedono anticipazioni o riscatti, anche parziali, delle somme accantonate.
La necessità dunque di sottoporre a vincolo delle somme, che diversamente potrebbero essere riscattate in via anticipata dal lavoratore, è prodromica ad una futura soddisfazione dei creditori, che diversamente vedrebbero frustrate le proprie ragioni.
Ove ciò non fosse possibile, questi ultimi, onde veder vincolate le somme, dovrebbero ripetutamente tentare pignoramenti, sperando che il lavoratore abbia chiesto un’anticipazione delle somme (e non l’abbia medio tempore ottenuta).
Il principio di diritto a cui la Suprema Corte giunge nella citata ordinanza, applicabile tanto ai lavoratori del settore privato quanto pubblico è dunque quello per cui anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l’Inps ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ.
*Avvocato in Milano

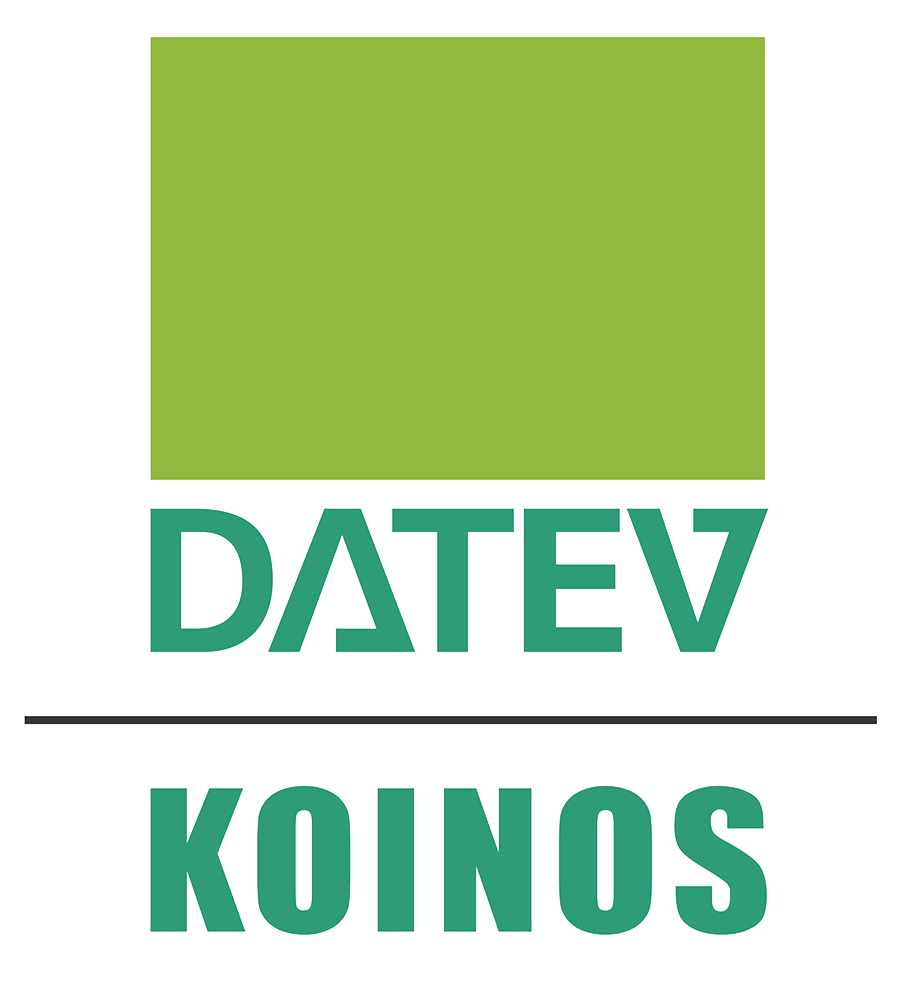






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!