Rassegna di giurisprudenza
dell’avv. Bernardina Calafiori*
Cass. Civ. Sez. lav., 27 maggio 2015, n. 10955 Estinzione e risoluzione del rapporto di lavoro subordinato – Licenziamento – Controlli difensivi – Legittimità.
Deve riconoscersi l’ammissibilità dei controlli difensivi “occulti”, anche ad opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, in quanto diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ferma comunque restando la necessaria esplicazione delle attività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, con le quali l’interesse del datore di lavoro al controllo ed alla difesa della organizzazione produttiva aziendale deve contemperarsi, e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale (nella specie, la Corte ha confermato la legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore sorpreso al telefono lontano dalla pressa cui era addetto, che era così rimasta incustodita per oltre dieci minuti e si era bloccata; inoltre era stata scoperta la sua detenzione in azienda di un dispositivo elettronico utile per conversazioni via internet ed in particolare, tramite la creazione di un falso profilo Facebook da parte dell’azienda, era stato accertato che durante l’orario di lavoro il dipendente aveva fatto accesso al social network.
La creazione del falso profilo Facebook non costituisce, di per sé, violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro, attenendo ad una mera modalità di accertamento dell’illecito commesso dal lavoratore, non invasiva né induttiva all’infrazione, avendo funzionato come mera occasione o sollecitazione cui il lavoratore ha prontamente e consapevolmente aderito).
Il caso deciso con il provvedimento in epigrafe riguardava il licenziamento per giusta di causa di un lavoratore al quale era stato contestato 1) di essersi allontanato dal posto di lavoro per una telefonata privata di circa 15 minuti, così omettendo di intervenire su una pressa che si era bloccata; 2) che nel suo armadietto aziendale era stato rinvenuto un dispositivo elettronico (IPAD) acceso ed in collegamento con la rete elettrica, 3) di essersi intrattenuto durante l’orario di lavoro a conversare su Facebook.
Il responsabile delle risorse umane della società aveva creato un falso profilo di donna su Facebook con richiesta di “amicizia” al lavoratore, con il quale aveva poi “chattato in più occasioni”, in orari che la stessa azienda aveva riscontrato concomitanti con quelli di lavoro del dipendente, e da posizione coincidente con la zona in cui aveva sede lo stabilimento della società.
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento e con l’ordinanza conclusiva della prima fase il ricorso veniva rigettato e veniva confermata la legittimità del licenziamento.
In esito al giudizio di opposizione promosso dal lavoratore il Tribunale, ritenuto che i fatti contestati non integrassero gli estremi della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo, dichiarava risolto il rapporto di lavoro condannando la società ad un risarcimento del danno pari a 22 mensilità.
In esito all’impugnazione di tale decisione promossa dalla società, la Corte d’Appello affermava che l’accertamento compiuto dalla società datrice di lavoro delle conversazioni via internet intrattenute dal ricorrente con il suo cellulare non costituisse violazione dell’art. 4,n. 300/1970 e, ritenuta la proporzionalità del provvedimento espulsivo alla luce dei fatti contestati, dichiarava legittimo il licenziamento.
Avverso la sentenza d’appello il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione adducendo, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 4, L.300/1970, assumendo che lo stratagemma utilizzato della società per accertare le conversazioni su Facebook durante l’orario di lavoro, costituisse un controllo a distanza vietato dalla norma.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso confermando la legittimità del licenziamento, affermando che nelle specie non può ritenersi violato lo Statuto dei Lavoratori.
La Corte ha premesso che l’esigenza di tutela della riservatezza del lavoratore sussiste anche con riferimento ai cosiddetti “controlli difensivi” ossia a quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al rapporto stesso, ove la sorveglianza venga attuata mediante strumenti che presentino quei requisiti strutturali e quelle potenzialità lesive, la cui utilizzazione è subordinata al previo accordo con il sindacato o all’intervento dell’Ispettorato del lavoro.
Tuttavia – afferma la Corte – “ove il controllo sia diretto non già a verificare l’esatto adempi- mento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, si è fuori dallo schema normativo dell’art. 4, L. n. 300 del 1970.”
E così la Corte ripercorre nella motivazione il panorama giurisprudenziale che ha affermato, a determinate condizioni, la legittimità di tali controlli, con riferimento, ad esempio, all’accesso da parte del datore di lavoro alla posta elettronica aziendale per verificare l’invio illecito a terzi da parte di un dipendente bancario di informazioni acquisite per ragioni di servi- zio o, ancora, con riferimento alla legittimità dei controlli occulti mediante l’utilizzo di una agenzia investigativa (purché vi sia il sospetto della commissione di un illecito e non si tratti di un mero controllo della prestazione lavorativa).
Dai precedenti giurisprudenziali la Corte trae il principio della “ammissibilità dei controlli difensivi “occulti”, anche ad opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, in quanto diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ferma comunque restando la necessaria esplicazione delle attività di accerta- mento mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, con le quali l’interesse del datore di lavoro al controllo ed alla difesa della organizzazione produttiva aziendale deve contemperarsi, e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale”.
La Corte ha quindi ritenuto che nella fattispecie concreta il datore di lavoro ha posto in essere un’attività di controllo che non aveva ad oggetto la prestazione lavorativa ed il suo esatto adempimento, ma l’eventuale perpetrazione di illeciti da parte del dipendente, che si erano già in parte manifestati nei giorni precedenti. Secondo la Corte “il controllo difensivo era dunque destinato ad riscontare e sanzionare un comportamento idoneo a ledere il patrimonio aziendale, sotto il profilo del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti (…) Né può dirsi che la creazione del falso profilo Facebook costituisca, di per sé, violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro, attenendo ad una mera modalità di accertamento dell’illecito commesso dal lavoratore, non invasiva né induttiva all’infrazione, avendo funzionato come mera occasione o sollecitazione cui il la- voratore ha prontamente e consapevolmente aderito”.
Tribunale di Como, 17 settembre 2015, n. 244 Iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti – Socio di società di persone – Abitualità e prevalenza dell’attività del socio – Verifica dei requisiti di cui all’art. 1, comma 203, L. n. 662/1996.
La prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all’apporto del soggetto all’attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all’attività prestata da altri soggetti al suo interno.
Tale assicurazione è posta a tutela di quelle situazioni accomunate al lavoro dipendente dall’espletamento di attività lavorativa abitua- le, nel suo momento esecutivo, connotando- si detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi all’interno dell’impresa).
Per affermare la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti devono in ogni caso sussistere tuti i requisiti previsti dall’art. 1, comma 203, L. n. 662/1996.
Il caso deciso con la sentenza in epigrafe ri- guardava il giudizio di opposizione ad avviso di addebito, notificato dall’INPS alla socia accomandataria di una s.a.s., previa iscrizione di ufficio alla gestione assicurativa degli esercenti l’attività commerciale.
L’iscrizione d’ufficio era stata disposta dall’En- te in quanto risultava apposta la sigla sulla Casella RK del modello Unico.
La ricorrente promuoveva ricorso in opposizione all’avviso di addebito deducendo che:
- la sigla in sede di dichiarazione dei redditi era stata apposta per mero errore;
- che non si era mai occupata della gestione ed amministrazione della società, che era pensionata ed occupata in incombenze familiari;
- che l’attività della società era limitata al godimento dei compensi derivanti dalla cessione del pacchetto clienti ad altra società.
La prova testimoniale confermava che la ricorrente era solo titolare della quota sociale, che non aveva mai avuto alcun potere di gestione e che mai si era occupata della gestione.
Il Giudice, ritenendo non sussistenti e non provati i requisiti di legge per l’iscrizione alla gestione previdenziale in questione e ritenendo che nessun valore confessorio potesse attribuirsi alla sigla apposta in sede di dichiarazione dei redditi, ha accolto l’opposizione, rigettando le pretese dell’INPS.
In particolare il Giudice, richiamando l’orientamento già espresso da Cass. Sez. Un. n. 3240/2010, ha espresso il principio riportato nella massima di cui sopra e confermato che l’obbligo contributivo è collegato all’esistenza della situazione di fatto che lo determina e, in particolare, alla comprovata esistenza in capo ai soggetti interessati dei seguenti requisiti di legge:
a)titolarità o gestione in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la fa- miglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b)sussistenza di piena responsabilità dell’impresa e assunzione di tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c ) partecipazione personale al lavoro azienda- le con carattere di abitualità e prevalenza;
d ) possesso, ove previsto da leggi o regola- menti, di licenze o autorizzazioni e/o iscrizione in albi, registri o ruoli.
Non ritenendo integrati nella specie tali requi- siti, il Giudice ha disatteso le pretese dell’INPS ed accolto il ricorso in opposizione all’avviso di addebito.
Cass. Civ. Sez. lav., 9 settembre 2015, n. 17832 Demansionamento – Lungo periodo di inattività – Danno patito – Risarcimento – dovuto Il danno patito dal lavoratore per effetto del demansionamento non discende in via automatica dall’inadempimento datoriale, e dunque non è in re ipsa, dovendo comunque essere provato.
La prova del pregiudizio subito può essere anche presuntiva non costituendo le presunzioni un mezzo di rango secondario nella gerarchia degli strumenti di prova, ben potendo pertanto essere impiegate anche in via esclusiva dal Giudice per la formazione del suo convincimento.
Il caso deciso con la sentenza in epigrafe riguardava una lavoratrice che, in esito al giudizio di merito, aveva ottenuto la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno da demansionamento.
Contro tale decisione proponeva ricorso in via incidentale il datore di lavoro, assumendo che nella specie non risultava provato il danno alla professionalità, non potendo lo stesso ritenersi in re ipsa per il solo fatto che vi era stato un inadempimento e un demansionamento.
Nella specie la lavoratrice era rimasta inattiva per un lunghissimo periodo, tuttavia secondo la prospettazione del datore di lavoro mancava la prova dello specifico danno subito.
La Corte ha respinto il ricorso, confermando il principio di cui alla massima in epigrafe. Nelle motivazioni la Corte ha ribadito:
a)che il danno da demansionamento non può ritenersi in re ipsa per il solo fatto che vi sia stato un demansionamento o un inadempimento del datore di lavoro, ma deve essersi verificato un effettivo detrimento della professionalità oggetto di specifica e separata prova, il cui onere incombe sul lavoratore;
b)la prova del danno può desumersi anche esclusivamente in via presuntiva, non essendo le presunzioni un mezzo di prova di rango inferiore agli altri strumenti di prova.
In particolare nella specie il danno alla professionalità poteva desumersi da elementi gravi, precisi e concordanti quali: a) il prolungato periodo di inattività per oltre ottantaquattro mesi, da considerarsi “la più grave violazione dell’art. 2103 c.c.”; b) l’assenza di conferimento di altri incarichi significativi.
In altre parole la prova del danno in casi limite come quello in esame finisce per ricavarsi in via presuntiva direttamente dalla natura (totale svuotamento di mansioni), dall’entità e dalla notevole durata del demansionamento, con conseguente affievolimento dell’onere della prova in capo al lavoratore.
* socio fondatore Studio Legale Daverio & Florio

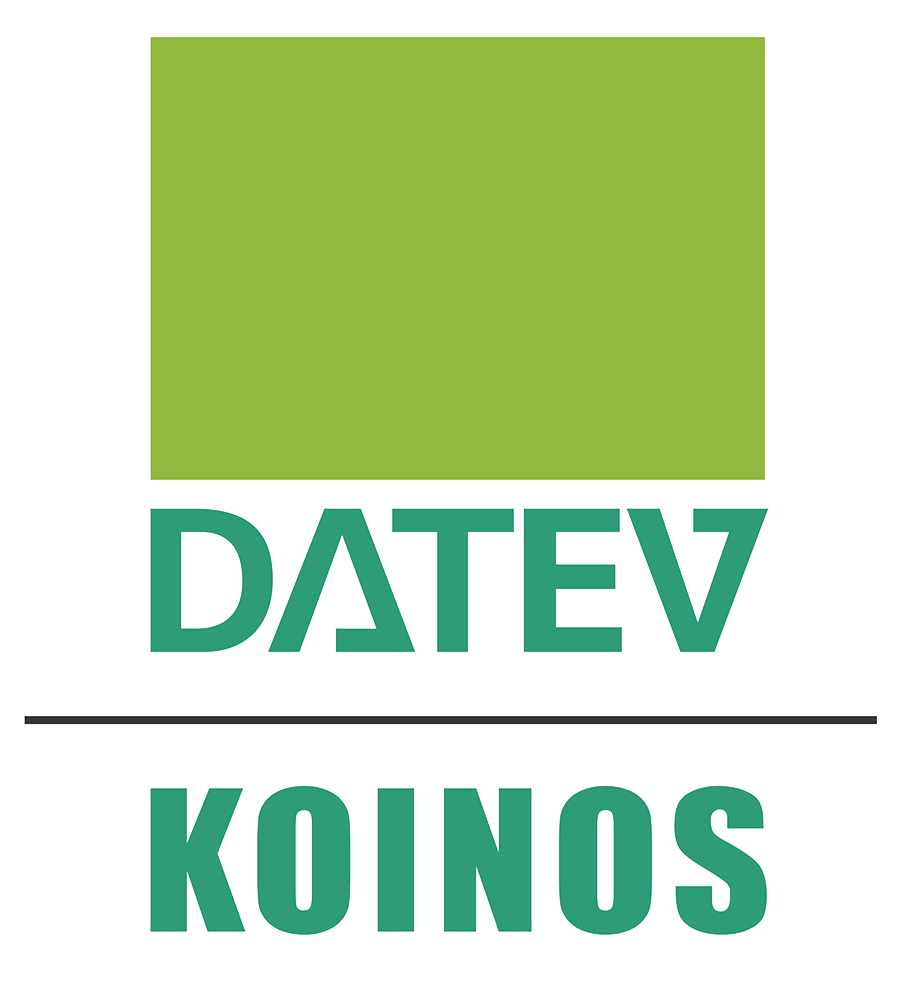






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!